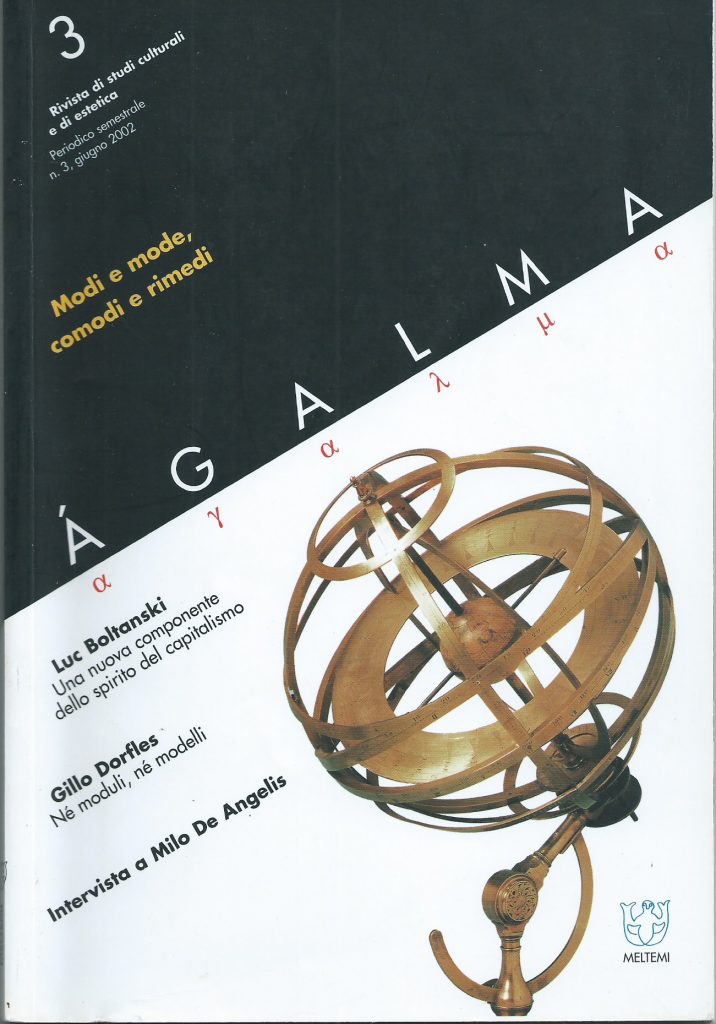Mario Perniola – Prova di forza o prova di grandezza? Considerazioni sull’agalma
Estetica ed economia
Le parti monografiche dei primi due numeri di “Ágalma”, che hanno per argomento il fascino delle merci e il lusso, sono riconducibili ad un ambito di interessi che ruotano intorno al rapporto tra estetica ed economia. Tale orizzonte è implicito nello stesso titolo della rivista: l’ágalma infatti rimanda alla nozione mitica del valore nell’economia premonetaria della Grecia antica, in una duplice accezione, che è insieme economica e simbolica. Come è noto, il primo aspetto è stato messo a fuoco dall’ellenista francese Louis Gernet nel saggio La nozione mitica del valore in Grecia (1948), il secondo dal filosofo delle religioni ungherese Karl Kerényi nel saggio Agalma, Eikon, Eidolon (1962). Oltre a questa radice storico-filologica, la problematica dell’ágalma è in qualche modo connessa con almeno altri due filoni culturali.
Il primo, di carattere antropologico-artistico, rimanda agli studi di Marcel Mauss (1924) sul dono come forma economica di scambio, di Georges Bataille (1949) sull’idea di un’“economia generale” (che si occupa dei fenomeni derivati dall’eccesso di energie, come il potlatch e il sacrificio, e perciò si contrappone all’economia ristretta il cui oggetto è la produzione e l’incremento delle ricchezze), di Paul Veyne (1976) sull’evergetismo antico, e più in generale a quella parte dell’avanguardia artistica e letteraria del Novecento che ha risentito l’influsso di tali argomenti (Clifford 1988). Il secondo filone culturale, di carattere storico-filosofico, è costituito dall’insieme di ricerche e di riflessioni intorno al rapporto tra estetica e società borghese, che vanno dallo studio sociologico di Norbert Elias (1939) dei processi di civilizzazione dei costumi agli studi di impostazione marxiana (Perniola 1971 e Eagleton 1990), o liberale (Ferry 1990) sull’origine della prospettiva estetica, dalle indagini sull’estetica delle merci (Baudrillard 1968; Haug 1971; Perniola 1980, Dorfles 1988) all’analisi sociologica dei dispositivi su cui si costruisce e si mantiene l’apprezzamento e l’ammirazione.
Tuttavia l’orizzonte aperto dalla nozione di ágalma non si esaurisce in questi riferimenti: su di essa infatti incombe la questione cruciale del rapporto tra società e valore con le sue complesse implicazioni di carattere critico (come è ancora possibile un giudizio sulle persone e sulle cose?), di carattere psicologico (attraverso quali dispositivi viene mobilizzata ed investita l’energia psichica degli individui in un clima sociale che favorisce le patologie connesse con la depressione e con la dipendenza?), e di carattere filosofico (come uscire dal nichilismo, che è apparso a tanti pensatori del Novecento il destino dell’Occidente?).
La nozione di ágalma dunque sollecita ed impegna competenze e conoscenze appartenenti a differenti campi del sapere visti nella loro interazione e confronto. Sembra perciò che siano proprio gli studi culturali il contesto in cui la questione del valore può essere esaminata e dibattuta (Connor 1992; Frow 1995). Tuttavia non deve essere sottovalutata l’obiezione di coloro che mettono in evidenza una certa incompatibilità tra la categoria della cultura, la quale è funzionale rispetto allo studio del collettivo dell’omogeneo e dello standardizzato, e la nozione di valore, la quale richiede la possibilità di pensare e di considerare la singolarità, la novità, la rarità e l’eccezionalità (Heinich 1998a).
Ciò risulta particolarmente evidente laddove è operante, come nelle arti, un’economia della grandezza che si basa non su dati quantitativi, ma su fattori qualitativi. Gli studi culturali, come le scienze sociali, sarebbero condizionati da un’ottica riduttivistica, che riporta sistematicamente l’eccezionale alla generalità dello standard o alla particolarità dell’interesse individuale: questa riduzione conterrebbe una valutazione negativa surrettizia, perché non esplicitata e forse nemmeno consapevole. Fatto sta che dall’interno stesso degli studi culturali e delle scienze sociali si va affermando una prospettiva antiriduzionistica, che mette in dubbio l’utilità euristica delle stesse nozioni di cultura e di società: esse sarebbero solidali con una concezione organica delle relazioni umane che risulterebbe ormai del tutto inadeguata alla comprensione delle attuali condizioni di esistenza. In altre parole, la cultura e la società sarebbero non qualcosa di reale e tantomeno entità paragonabili a organismi naturali, ma mere costruzioni concettuali connesse a strategie di culturalizzazione e di socializzazione ormai superate.
La vexata quaestio del rapporto tra il valore da un lato e la società o la cultura dell’altro, che tanto ha oscillato tra soluzioni essenzialiste e soluzioni relativiste, diventerebbe improponibile per il dissolversi di uno dei due termini del confronto. E a svanire questa volta non sarebbe il valore, ma la società e la cultura! Per quanto concerne l’estetica, questa nuova prospettiva antiriduzionistica segna l’eclisse di quelle teorie sociologiche che pretendono di spiegare l’arte mediante la sua iscrizione in una storia sociale, oppure il gusto estetico mediante l’interiorizzazione di condizionamenti derivati dall’appartenenza di una determinata classe sociale, o le opere mediante l’azione esercitata sull’artista dalla molteplicità di fattori teorici e pratici che condizionano i mondi dell’arte. Queste teorie non consentirebbero di spiegare ciò che più importa nell’arte, cioè il suo valore. In altri termini, gli studi culturali e le scienze sociali per affrontare adeguatamente la questione del valore dovrebbero mettere da parte le nozioni su cui si sono fondati finora, rispettivamente quella di cultura e quella di società. La riflessione intorno al valore ritornerebbe così al suo punto di partenza, che è quello economico-simbolico, cioè all’ágalma.
I tre spiriti del capitalismo
A questa problematica viene impressa una svolta decisiva dal monumentale volume di Luc Boltanski e Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme (1999, pp. 844), che spiega in modo estremamente ingegnoso e documentato la natura del legame esistente nella società attuale tra economia ed estetica.
Il presupposto su cui si regge quest’opera ambiziosa risale a Max Weber (1920) e al suo libro sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo. Anche per i nostri autori il capitalismo non è la semplice passione di accumulare denaro all’infinito, ma ha un suo spirito. Se la sua definizione minima, mettendo l’accento su un’esigenza di accumulazione illimitata con mezzi formalmente pacifici, mostra il suo carattere essenzialmente dinamico, la realizzazione dei profitti deve tuttavia avvenire secondo modalità che pretendono di essere legittime. Il capitalismo è un sistema così contrario alla naturale tendenza verso il piacere e l’uso, che per affermarsi e mantenersi ha bisogno di una giustificazione (Boltanski – Thévenot 1991).
Esso, infatti, a differenza dell’economia schiavistica, implica una sottomissione volontaria ad una logica che si impone nella sua autonomia tanto al capitalista che al salariato; perché ciò avvenga è necessaria una partecipazione ed un impegno che vanno molto al di là del semplice istinto di autoconservazione. Se il capitalismo non limitasse e frenasse la propria spinta propulsiva verso l’accumulazione finirebbe con l’autodistruggersi: le costrizioni e i limiti fanno parte della sua essenza. Lo spirito del capitalismo non è perciò una sovrastruttura, ma gioca un ruolo centrale nella sua dinamica economica, la quale aspira alla legittimità: infatti non ogni profitto è legittimo, non ogni arricchimento è giusto, non ogni accumulazione è lecita! Potrebbe sopravvivere il capitalismo senza la proibizione del furto?
A questi aspetti, già impliciti in Weber, i nostri autori aggiungono un altro elemento assai originale: il capitalismo ha in se stesso non solo l’esigenza del limite, ma anche quella della critica: esso ha in qualche modo “bisogno dei suoi nemici, di coloro che sono da lui indignati e che gli si oppongono, per trovare i punti d’appoggio morali che gli mancano e incorporare i dispositivi di giustizia la cui pertinenza senza ciò non avrebbe alcuna ragione di riconoscere” (Boltanski, Chiapello 1999: 69). L’anticapitalismo accompagna il capitalismo come la sua ombra e lo costringe a formulare i propri programmi con riferimento al bene comune, secondo principi universali. Viene così riconosciuta alla critica un’efficacia reale: non a caso, la conclusione del volume si intitola “forza della critica”! I nostri autori assumono così una posizione rigorosamente antideterministica: a loro avviso, le condotte umane non sono affatto rette da forze esterne che agiscono indipendentemente dalle volontà singole! Parimenti rifiutato è il punto di vista culturalista, che attribuisce ai membri di una determinata cultura una conformazione identica, sicché essi agiscono all’unisono senza concertazione; il culturalismo attribuisce alle norme interiorizzate un potere troppo grande e in fondo pensa le società umane come gruppi di babbuini! Più in generale essi rifiutano tutte quelle concezioni organicistiche e neodarwinistiche per le quali il corso della storia è retto da forze fatali e impersonali.
Il discorso di Boltanski e Chiapello va al di là di Max Weber su un altro punto fondamentale: il capitalismo fondato sulla vocazione (Beruf), sul lavoro e sul risparmio, descritto da Weber, appartiene alla prima fase del suo sviluppo, la quale si estende fino ai primi decenni del Novecento. Successivamente il capitalismo avrebbe subito due profonde trasformazioni: la prima si è manifestata intorno agli anni Trenta e può essere considerata come una risposta alle critiche del movimento socialista ed operaio; la seconda si è manifestata intorno agli anni Ottanta e costituisce una risposta alle critiche provenienti dall’arte e dall’estetica, le quali trovarono nella contestazione e nel Sessantotto la loro massima espressione. Il capitalismo risulta dotato quindi di ben tre spiriti differenti!
Mentre il primo spirito è concentrato sulla persona del borghese imprenditore e sulla descrizione dei valori patriarcali, il secondo spirito mette l’accento sull’organizzazione, la quale costituisce l’aspetto fondamentale della grande impresa industriale centralizzata e burocratica, nella quale il direttore, cioè il dirigente salariato, gioca un ruolo primario.
In questa seconda fase del capitalismo i bisogni di giustizia e di sicurezza, di cui si era fatto interprete il movimento socialista e operaio vengono relativamente recepiti: è l’epoca dei sindacati forti, dello stato sociale, del posto fisso, della competenza professionale riconosciuta, della grande azienda che fornisce protezione e garantisce le carriere. Il gigantismo e la burocratizzazione delle organizzazioni costituiscono ambiti protettivi che si fanno carico anche dell’organizzazione della vita quotidiana dei dipendenti secondo il modello dell’esercito (p. 56). Ma questo modello di sviluppo entra in crisi nel corso degli anni Sessanta e Settanta scontrandosi con le richieste di autonomia, di creatività, di autenticità e di liberazione, che fino ad allora erano state sostenute dagli ambienti artistici, letterari e più in generale estetici e che solo in quel momento storico trovano un’adesione di massa: i nostri autori definiscono questo tipo di critica del capitalismo con l’espressione critique artiste, distinguendola dalla critique sociale, che fa leva sui bisogni di sicurezza e di giustizia. Nel decennio ’68-’78 le due critiche procedono insieme, provocando la crisi del secondo modello capitalistico, fondato sull’ordine e sulla burocrazia: in quegli anni si assiste alla disorganizzazione della produzione, alla perdita di controllo delle aziende, alla moltiplicazione dei conflitti sociali, al rifiuto dell’autorità e perfino del lavoro.
Negli anni Settanta in Francia e in Italia il padronato cerca un rimedio a questo dissesto appoggiando la critica sociale e criminalizzando la critica estetica. Ma questa strategia si rivela perdente: la grande politica contrattuale, malgrado il suo costo, non riporta la pace sociale e non riporta ordine nella produzione. Perciò, alla fine degli anni Settanta si verifica una brusca inversione di tendenza: il capitalismo tende a fare proprie le rivendicazioni estetiche e nasce così il terzo spirito del capitalismo. Questa inversione di tendenza si manifesta precocemente anche in Italia nella nuova strategia aziendale adottata dalla Fiat nei primi anni Ottanta.
Nella sua terza manifestazione, che occupa gli ultimi vent’anni del Novecento, il capitalismo da un lato accoglie le istanze estetiche e cerca di dar loro soddisfazione, dall’altro decostruisce il mondo del lavoro e delle categorie socio-professionali così come si era costituito a partire dall’Ottocento. In primo luogo riconosce l’esigenza dell’autonomia fino a farne un valore assolutamente centrale del nuovo ordine produttivo. La ripresa del controllo delle aziende avviene non attraverso un aumento del potere della gerarchia, ma al contrario mediante lo sviluppo dell’autocontrollo e la creazione di team nei quali i lavoratori si sorvegliano a vicenda; viene introdotta una nozione chiave del management attuale, la flessibilità (lavori a tempo parziale, orari elastici, responsabilizzazione nei metodi e nelle soluzioni ecc.). In questo modo viene incrementata a tutti i livelli la creatività e si dà l’impressione, a tutti i salariati, di partecipare su un piano di uguaglianza relativa, ad un’impresa eccitante e d’avanguardia. Il manager creativo si pone come l’erede dell’artista bohémien: esperienze maturate in ambiti marginali, trasgressivi o rivoluzionari, sono ritenute molto utili ai fini dello sfruttamento capitalistico di settori non ancora o debolmente mercificati.
Il capitalismo ricupera anche la domanda di autenticità facendo propria la critica alla massificazione che caratterizza il secondo spirito del capitalismo: le forme di organizzazione del lavoro di tipo tayloriano, cioè strutturate sulla base della catena di montaggio, sono sostituite da procedure meno frustranti e più articolate. Inoltre viene posta una grande attenzione nel fornire al consumatore una vasta gamma di prodotti che possono essere ulteriormente personalizzati attraverso numerose opzioni. Il terzo spirito del capitalismo poi trae un grande impulso dalla mercificazione dell’autentico attraverso una serie di fenomeni che vanno dalla produzione di “ecoprodotti” e di alimenti biologici al turismo “d’avventura”, dal boom dei musei e delle esposizioni d’arte all’espansione dell’industria culturale, dal grande successo della moda all’esplosione di una “febbre di lusso”. In questa strategia rientra anche il movimento New Age che è una specie di trasformazione dello spirituale in business.
Infine il capitalismo si alimenta in somma misura dall’esigenza di liberazione, portando avanti una dinamica che gli è appartenuta fin dalle origini più remote: esso infatti si è contrapposto alle società tradizionali che legavano gli individui ad uno stato sociale fisso, consentendo loro di scegliere attraverso il contratto il loro modo di appartenenza alla società. Il capitalismo ha liberato gli attori sociali dall’obbligo di prendere e di dare, implicito nella logica del dono e del potlatch: infatti nessuno è obbligato a comprare o a vendere e il mercato del lavoro si presenta come “un dispositivo favorevole alla realizzazione di un ideale di autonomia” (p. 511). Mentre il secondo spirito del capitalismo ha puntato sui bisogni di sicurezza e di giustizia attraverso la pianificazione e la burocratizzazione, la spinta verso la liberazione ritorna prepotentemente nel terzo spirito del capitalismo, il quale perciò si mostra insofferente nei confronti di tutti i limiti e i divieti, a cominciare da quelli sessuali (come risulta evidente nel boom della pornografia).
Occorre tener presente che la ricerca dei nostri autori ha un fondamento statistico: infatti, si basa sull’esame dei trattati di management. Sono stati individuati una sessantina di testi pubblicati negli anni Sessanta e altrettanti pubblicati negli anni Novanta. Da questi sono stati tratti due corpora di dimensioni pressappoco uguali, che sono diventati oggetto di uno studio analitico e di una indagine statistica svolta grazie ad un trattamento informatico che combina l’approccio lessicografico con l’approccio ermeneutico, permettendo la codificazione e la costruzione interattiva di categorie (persone, esseri collettivi, oggetti, azioni…) e l’elaborazione di rappresentazioni adattate insieme ai testi e alla problematica della ricerca. La loro tesi sul terzo spirito del capitalismo si fonda quindi sullo studio scientifico di testi prescrittivi: dal confronto tra i due corpora si ricava che mentre i testi degli anni Sessanta sono permeati da un esprit de géométrie, che si esprime in alcune parole chiave come “quadri”, “dirigenti”, “subordinati”, “capo”, i testi degli anni Novanta sono permeati da un esprit de finesse, che si manifesta in parole chiave come “rete”, “squadra”, “progetto”, “manager”.
II paradigma della rete e la decostruzione del mondo del lavoro
Il ricupero della critica estetica è solo un aspetto del terzo spirito del capitalismo, la cui logica è pienamente comprensibile solo a partire dal momento in cui si coglie il paradigma su cui si regge, che è quello della rete. Tale nozione acquista un rilievo mai avuto prima: l’arte della mediazione viene autonomizzata e valorizzata per se stessa e diventa il principio superiore comune secondo il quale sono giudicate le persone, le azioni e le cose. La rete crea, secondo i nostri autori, un nuovo tipo organizzazione politica, una nuova città che va ad aggiungersi ai sei tipi individuati da Boltanski nella sua opera precedente: dopo le città dell’ispirazione, domestica, dell’opinione, civica, mercantile ed industriale, si configura “una città per progetti”, un mondo reticolare costruito sulla moltiplicazione di incontri e di connessioni temporanei, ma riattivabili. “Il progetto è l’occasione e il pretesto della connessione” (p. 157); esso permette la produzione e l’accumulazione in un mondo “che se fosse puramente connessionista non conoscerebbe altro che flussi senza che nulla possa stabilizzarsi, accumularsi o prendere forma”.
Il progetto è la tasca di accumulazione temporanea, che essendo creatrice di valore “dà un fondamento all’esigenza di estendere la rete favorendo le connessioni”. Una delle prime conseguenze di questa nuova logica è la scomparsa della differenza tra lavoro e tempo libero. Questa opposizione, tipica delle prime due forme di capitalismo, viene assorbita dalla nozione complessiva di attività, che si pone al di là delle contrapposizioni tra impiego e volontariato, tra interesse e disinteresse, tra salariato e non salariato. Nei libri di management viene introdotta l’idea di un portafoglio di attività, articolato in lavoro salariato, liberale, domestico, benevolo ed educativo. Queste attività si intersecano le une con le altre e devono essere condotte mostrando entusiasmo e disponibilità ad inserirsi e ad integrarsi nei progetti iniziati da altri. La nozione di interesse riacquista così il suo significato originario di “essere tra”, cioè al di là della distinzione tra vantaggio e svantaggio, utile e inutile. La nozione di capitale sociale, cioè dell’insieme delle relazioni di cui uno dispone, risulta più importante di quella di capitale umano, cioè della preparazione e delle potenzialità professionali.
Ciò comporta alcune conseguenze inaspettate. In primo luogo, salta la separatezza tra vita professionale e vita privata, su cui si fondava lo spirito del secondo capitalismo: l’adattabilità, la flessibilità, la polivalenza immerge in un turbine di rapporti e di connessioni di cui per lo più non si sa che aspetto finiranno con l’assumere. Ciò implica una personalizzazione molto accentuata del lavoro e una difficoltà di delega: l’attività è inseparabile dalla persona che la svolge. Ora dato che le energie e il tempo del singolo sono limitati, si impone una scelta; ma scegliere in un contesto così mobile e cangiante è difficile. Come osservano giustamente i nostri autori, nel mondo del capitalismo connessionista, vige sempre una grande incertezza sul risultato finale dello scambio (p. 197). In un mondo che offre infinite possibilità di collegamenti, quali sono i criteri della selezione? Secondo i manuali di management, occorre favorire le connessioni più lontane e più improbabili e non farsi incastrare in quelle più ovvie e più prossime; mantenersi il più possibile mobili e leggeri e soprattutto far funzionare le orecchie come sensibilissime antenne, pronte a cogliere ciò che emerge alle sue primissime manifestazioni. Il successo nel mondo connessionista dipende dall’anticipazione e dalla capacità di riempire i cosiddetti “buchi strutturali”, cioè le zone in cui le mediazioni sono rare o inesistenti.
Sotto un certo aspetto il terzo spirito del capitalismo realizza una richiesta della critica estetica dell’epoca della contestazione, la fine del lavoro. La condizione dell’artista inteso come outsider e imprenditore di se stesso si estende a tutti coloro che vogliono giocare un ruolo significativo nel mondo attuale. Ma ciò non deve essere inteso come un trionfo dell’individuo. Secondo i nostri autori, il terzo spirito del capitalismo non deve essere confuso col liberalismo né con l’individualismo, che sono semmai riportabili alla prima età del capitalismo. Gli individui si rivelano sempre meno pertinenti delle relazioni che li legano: “nell’analisi delle reti sociali, i legami interelazionali tra gli attori sono primari e i loro attributi secondari” (p. 688 nota 39). Si possono studiare le reti senza fare riferimento agli attributi degli individui che sono in esse impegnati. Perciò tentativi (come quello di Habermas) di riprendere l’eredità kantiana per fondare la possibilità di un giudizio formulato in termini di verità o di giustezza morale sono inadeguati ad affrontare una situazione in cui la nozione di soggetto è completamente dissolta, sia essa intesa in senso individualistico sia in senso collettivistico (come classe, gruppo o genere). Parimenti inadeguate sono le concezioni strutturali della società che cercano di individuare le forme originarie e stabili che stanno alla base della vita collettiva: la rete non è un sistema, né una struttura, né un mercato, né una comunità.
Il paradigma della rete è stato per lo più inteso in senso negativo dalla tradizione del pensiero politico come sinonimo di legame clandestino illegittimo e illegale (si pensi alla polemica di Rousseau contro le brigues, cioè gli intrighi, oppure alle accuse rivolte ai gesuiti, ai massoni, agli omosessuali, agli ebrei, ritenuti colpevoli di tessere trame occulte). Per i nostri autori invece lo spirito del capitalismo connessionista è differente da quello della mafia, perché aspira alla legittimità. Esso contiene in se stesso, non diversamente dalle due forme precedenti di capitalismo, elementi di autocritica e di autocorrezione, individuabili, a loro avviso, soprattutto nel bisogno di fiducia e di reciprocità che soli consentono l’espansione e lo sviluppo delle reti. Qui cade appunto la differenza tra mailleur e faiseur, cioè tra l’individuo intraprendente e il faccendiere: solo il primo può aspirare alla grandezza, mentre il secondo facendo un uso opportunista e cinico delle relazioni, finisce col muoversi secondo una logica soggettiva che è differente da quella della rete.
La concezione reticolare del legame sociale implica una vera e propria decostruzione del mondo del lavoro che si manifesta in molti modi. A differenza delle grandi aziende capitalistiche del passato, oggi un’impresa è tanto più redditizia quanto più è mobile, leggera e formata da poche persone qualificate disposte a muoversi e ad agire rapidamente. Ne deriva una dualizzazione del salariato tra i pochi che solo interiorizzano le finalità della ditta e i molti che sono assunti temporaneamente per la realizzazione di progetti specifici limitati nel tempo, i quali vedono degradata la loro situazione economica, stabilità professionale e posizione sociale. La selezione tra i primi e i secondi avviene sulla base della capacità di introiettare la logica reticolare del terzo capitalismo e di adeguarsi ad essa anche nello stile di vita in termini di disponibilità, flessibilità ed impegno: ne deriva il culto della performance, l’esaltazione della mobilità e la passione dell’estremo, tutti caratteri peraltro che appartengono per eccellenza all’avanguardia artistico-culturale del Novecento. Questi fenomeni si accompagnano a un processo di desindacalizzazione: gli aumenti di salario tendono ad essere negoziati direttamente con i singoli salariati che rispondono alle caratteristiche richieste.
La contrattazione politica e collettiva gestita dai sindacati perde importanza: tramonta anche lo schema teorico fondamentale su cui si basava l’azione dei sindacati, cioè la rappresentazione della società in termini di classi sociali e di categorie socio-professionali. Il mondo del lavoro si disfa: i dirigenti di azienda risultano essere assai meglio informati dei dirigenti sindacali, i quali soffrono di irrealismo, incompetenza e strettezza di vedute. Venendo meno l’intermediazione tra datori di lavoro e salariati, il terreno della conflittualità si sposta dall’ambito sindacale a quello giuridico: la mancanza di intermediari provoca l’aumento delle cause, col risultato di ingolfare i tribunali e rendere ancora più problematico il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. La precarizzazione degli statuti e la paura della disoccupazione rendono ancora più incerta la posizione degli esclusi, impedendo il costituirsi di forme di solidarietà organizzata.
Molto interessante è l’analisi, svolta da Boltanski e Chiapello, delle origini dell’idea della società articolata in classi. Essa non è un’eredità della rivoluzione francese: infatti la sua rappresentazione civica, di ispirazione rousseauiana, considera il cittadino privo di ogni appartenenza locale o professionale, la quale rinvia ad interessi particolari diversi dall’interesse generale; il cittadino è un uomo senza qualità, determinato soltanto dalla sua appartenenza alla nazione. La società intesa come insieme di classi sociali ha invece tre fonti teoriche: il corporativismo, di cui una componente importante è il cattolicesimo sociale, il movimento sindacale e la corrente tecnocratica pianificatrice di ispirazione saintsimoniana (p. 377). Essa si è costituita attraverso varie tappe che vanno dall’organizzazione sociale per mestieri alla separazione tra salariati e non salariati fino alla scansione attuale che differenzia gli operai (articolati in manovali, specializzati e qualificati) dagli impiegati (articolati in impiegati semplici, professioni intermediarie, dirigenti e professioni intellettuali superiori).
Ora è proprio questo ordinamento socio-professionale della società che il nuovo capitalismo mette in crisi. Da un lato esso tende a far saltare la separazione rigida tra operai e impiegati, dall’altro smantella la categoria dei dirigenti. Infatti intervengono molti fattori nuovi. In virtù dello sviluppo tecnologico, molti operai qualificati (a cui conviene maggiormente il nome di “operatori”) hanno responsabilità superiori a quelle dei dirigenti; a causa dello sviluppo del terziario, il numero degli operai è diminuito, mentre quello dei dirigenti è aumentato; inoltre gli ambienti sociali si sono omogeneizzati e non esistono più differenze notevoli tra gli stili di vita degli operai e quelli degli impiegati; a ciò si aggiunge l’attenuazione dei rapporti gerarchici, la svalorizzazione dei diplomi universitari, il passaggio dall’organizzazione taylorista del lavoro a quella flessibile e modulare. Queste trasformazioni segnano l’eclisse del sistema professionale fondato sull’idea che la classe dirigente deve essere formata secondo i metodi scientifici del sapere universitario.
Il nuovo capitalismo ha ancora bisogno di professori universitari?
La decostruzione del sistema scientifico-professionale porta con sé la crisi dello statuto del professore universitario. Per cui sorge la domanda se il capitalismo abbia ancora bisogno di professori universitari. Delineando nel mio libro Dopo Heidegger i caratteri del sistema scientifico-professionale scrivevo quanto segue: “Ciò che caratterizza tale sistema è insieme la socializzazione radicale della scienza, per cui questa non è più vista come una investigazione personale e privata del singolo, ma come un’impresa in cui tutta la società è coinvolta e da cui dipende il suo destino, e una scientificizzazione altrettanto radicale della società, per cui la condizione di ogni azione efficace implica una completa subordinazione ai criteri, alle prospettive e ai procedimenti della conoscenza scientifica” (Perniola 1982: 44). In altre parole la scienza si costituisce come professione parallelamente al costituirsi della professione come scienza. “Questa coappartenenza – continuavo – risulta evidente nell’università moderna e nella figura del professore universitario, che è insieme docente e ricercatore, docente di un sapere professionale proprio perché professionalmente dedito all’incremento di questo sapere, e ricercatore di una conoscenza sperimentale al servizio di tutti perché libero professionista della scienza.
Viceversa la riduzione del professore ad impiegato dell’università è parallela alla recisione di ogni legame tra attività professionale e ricerca: tale fenomeno mostra a contrario in primo luogo che la dimensione scientifica che distingue il professore dall’insegnante è proprio derivata dal carattere professionale delle conoscenze che egli trasmette e in secondo luogo che la dimensione etica che distingue il professionista dagli altri lavoratori è proprio derivata dal carattere scientifico delle conoscenze che detiene”. La scienza e la professione formano una struttura le cui singole parti sono inseparabili l’una dall’altra. È quindi più che legittimo il sospetto che nella decostruzione attuale del lavoro professionale venga meno anche la possibilità di esercitare la scienza come professione, cioè che il capitalismo non abbia più interesse a mantenere in piedi un sistema così costoso come quello scientifico-professionale e intenda degradare l’università a scuola superiore e i professori universitari ad impiegati.
Di questa preoccupazione si è fatto interprete Jean-Claude Milner nel suo volume Le salaire de l’idéal (1997). Secondo Milner, il Novecento ha visto il successo della borghesia salariata: mentre il borghese era nell’Ottocento soprattutto un benestante che viveva di rendita, l’esplosione tecnologica del Novecento fornisce la base di un mutamento sociale, che vede emergere la figura del dirigente, dell’ingegnere, del funzionario. Ora il borghese salariato viene pagato di più dell’operaio salariato: si tratta però di un prezzo “politico” largamente indipendente dal mercato. Così come oggi l’alto salario pagato ai presentatori della televisione non ha nessuna giustificazione economica. La chiave per comprendere il meccanismo che legittima questo plus-salario è l’università, la quale aveva il compito di accrescere il numero dei borghesi. La crisi dell’università dunque si identifica con la crisi della borghesia, la quale vede scomparire la legittimazione della propria condizione. Secondo Milner il capitalismo può oggi fare a meno delle classi medie che sono troppo costose: la tradizionale coappartenenza tra capitalismo e borghesia si è spezzato: “le università possono forse sopravvivere; queste istituzioni sono nate in tempi difficili e hanno attraversato molte tempeste. La difficoltà più grande è per la borghesia diplomata; privati di ogni titolo permanente al plus-salario, i suoi membri dovranno affrontare direttamente la legge del mercato. Ma essi non hanno nulla da vendere che sia raro (nulla di più corrente oggi che la competenza) e dunque caro” (p. 108).
Dall’opera di Boltanski e Chiapello invece si ricava un’altra risposta. Infatti a loro avviso anche il nuovo capitalismo possiede uno spirito, cioè una razionalità che è molto più complessa e difficile di quella delle sue due forme precedenti. Esso richiede una quantità e una varietà di attitudini e di competenze molto più numerose e più varie del passato: soprattutto esige una capacità di sintesi e di discriminazione che proprio gli studi umanistici dovrebbero poter offrire. Per quanto essi non affrontino la questione della formazione e della trasmissione del sapere nell’età del terzo capitalismo, tuttavia le loro tesi sono estremamente illuminanti se vengono trasposte sul piano della politica universitaria. Infatti è da tempo operante in molti paesi la tendenza a considerare l’università come un’azienda e ad applicare ad essa gli stessi principi di management che stanno alla base del terzo spirito del capitalismo. Questa tendenza si è manifestata anche in Italia nel corso degli ultimi anni. A mio avviso, il problema centrale è se l’università in generale (e più specificamente le facoltà umanistiche) possa diventare in grado di sviluppare e di trasmettere conoscenze e metodologie che abbiano quei caratteri di flessibilità, di agilità e di ingegnosità che caratterizza la mentalità dell’economia attuale. Certo è che il sistema scientifico-professionale su cui si reggeva l’università del passato garantiva insieme la professionalità della ricerca e l’utilità sociale dell’etica scientifica; questa connessione deve essere mantenuta. Se il mondo perde la capacità di vedere con un occhio distaccato e disinteressato (e questa è in fondo l’eredità fondamentale degli studi umanistici e scientifici), se tutto precipita nella faziosità degli interessi e delle dispute personali, se viene meno ogni riferimento al bene comune, insieme all’università perisce anche la vita civile.
Il nuovo capitalismo ha ancora bisogno di politici?
Se i destini del sapere scientifico sono minacciati dal terzo spirito del capitalismo, che ne è della politica ideologica? La rappresentazione della società in termini di destra e sinistra, progressisti e conservatori, sembra grandemente compromessa dal terzo spirito del capitalismo. Boltanski e Chiapello sottolineano il fatto che in Francia la strategia della flessibilità ha trovato molti sostenitori proprio tra le file dei militanti di sinistra che hanno integrato nella loro cultura le domande del padronato (Boltanski, Chiapello 1999: 283). In modo assai pessimistico Jean-Claude Milner sostiene che ormai la borghesia sa di essere vinta dal capitalismo: coloro che si credevano dalla parte dei vincitori, si scoprono dalla parte dei vinti: “imploravano per gli altri, ormai implorano per se stessi. L’incredibile voga del discorso caritatevole non ha altra origine. Quanto alla scena parlamentare, essa scopre con sorpresa che la ripartizione tra destra e sinistra non si opera più in termini di capitale, gli uni a favore gli altri contro. Una sola questione si pone: quale partito sarà il più efficace difensore del sursalario?” (Milner 1997: 117-8). Secondo Milner in Francia è la sinistra, tradizionale difensore della funzione pubblica e protettrice naturale di ogni categoria minacciata, a proteggere meglio la borghesia e a salvarla dalla legge di ferro del capitale: “Se la Francia vota così sovente a sinistra, è per la stessa ragione per cui essa vota così sovente a destra: è perché essa è il paese più borghese del mondo” (p. 118).
In realtà nella politica si rispecchiano le contraddizioni del legame che collega la borghesia al capitalismo, messe in evidenza da tutta una lunga tradizione di studi marxiani: essa si vuole partito d’ordine pur rovesciando continuamente e senza scrupoli le condizioni d’esistenza e si appropria delle critiche più radicali trasformandole in merci. Si spiega così il fatto che tanto la destra quanto la sinistra siano dilaniate da scelte e da strategie del tutto incompatibili tra loro. L’intero discorso politico-ideologico, ereditato dalla Rivoluzione francese, si rivela inadeguato a comprendere la complessità e il carattere paradossale dei processi in atto. Ciò non vuol dire però che la teoria politica sia completamente disarmata rispetto a un mondo che sembra interamente dominato dall’economia. Molto interessante è per esempio la distinzione fatta da Boltanski e Chiapello tra riformismo e radicalismo: essa si fonda sulla distinzione delle sette città politiche (di cui si è detto sopra) e sulla individuazione per ciascuna di esse di un principio di grandezza differente. Il riferimento alla grandezza è essenziale, perché fonda la legittimità dell’ordinamento e quindi il suo carattere politico-filosofico (cioè il fatto che esso sia orientato verso il bene comune). La grandezza viene misurata attraverso una prova legittima, vale a dire specificata e controllata, nella quale sono stati determinate le classi degli esseri che possono essere ammessi ad essa e le regole che presiedono al suo svolgimento. Ora la critica riformista è quella che vuole migliorare la giustizia della prova, cioè elevare il suo livello di convenzionalizzazione e sviluppare il suo inquadramento regolamentare. La critica radicale (o rivoluzionaria) è invece quella che vuole eliminare la prova e sostituirla con un’altra appartenente ad un’altra città. Nel primo caso la critica prende sul serio la prova e intende migliorarla; nel secondo la prova stessa viene contestata perché si rifiuta la città in riferimento alla quale la prova è costruita.
La crisi assiologica che noi stiamo vivendo potrebbe perciò essere interpretata come un momento di passaggio tra città differenti (da quella mercantile e industriale del vecchio capitalismo a quella connessionistica del nuovo capitalismo): le antiche prove sono disorganizzate e decostruite, mentre le nuove sono ancora poco identificate e per nulla controllate. Ne deriva una situazione di anomia, caratterizzata dall’indebolirsi del legame sociale, dalla difficoltà a proiettarsi nell’avvenire, dall’incertezza sulle azioni da intraprendere, dalla “perdita del senso della vita”, del quale il postmodernismo sarebbe la manifestazione culturale. Nella misura in cui il nuovo spirito di capitalismo pretende di essere legittimo, dovrà necessariamente trovare una logica politica che stabilisca una scala di grandezze determinata sulla base di prove determinate e controllate. La risposta finale sembra quindi abbastanza ottimistica: il tramonto della politica ideologica non implica affatto il tramonto della politica intesa come ricerca del bene collettivo.
La prova di grandezza
C’è però una difficoltà: nel corso degli ultimi trent’anni la critica è andata al di là del riferimento ad una qualsiasi città politica, e quindi al di là di ogni idea di grandezza: essa ha rivendicato un mondo senza prove e senza giudizi. In questa contestazione della stessa nozione di prova si sono trovati convergenti il comunismo utopico, che prefigura una società dell’abbondanza, il politicamente corretto, che esime da ogni sforzo e tende a trasformare ogni handicap in un vantaggio, nonché il corporativismo, che contro la logica della performance fa valere le prerogative dello statuto di appartenenza. La posizione sostenuta da Boltanski e Chiapello mira invece ad affermare la necessità di una prova di grandezza: laddove si nega la possibilità di qualsiasi prova di grandezza, si lascia spazio soltanto alla forza (Boltanski, Chiapello 1999: 401); il che vuol dire prescindere completamente da ogni esigenza di legittimità e di giustizia e dalla loro eventuale effettualità. “Un universo in cui le regole non sono sicure per nessuno è un universo che permette ai forti dotati di forze diverse e non specificate di avere la meglio sui deboli, la natura della debolezza dei quali è perfino difficile da definire” (p. 409). “Bisogna rinunciare a vincere con qualsiasi mezzo” (p. 75).
È questo il pericolo insito nelle teorie del disincanto e della demitizzazione, di derivazione marxista o nietzschiana che hanno prevalso nell’ultimo trentennio del Novecento. Le teorie che vedono nella società soltanto rapporti di forza, violenza, sfruttamento, lotta e dominio di interessi sono riduzionistiche e omogeneizzanti: schiacciano sul fattuale, rendono impossibile il perseguimento dell’“arduum et difficile” e quindi nemmeno capiscono la spinta all’innovazione che proviene dal capitalismo. Viceversa, le teorie che in reazione al nieztsche-marxismo si focalizzano sull’analisi dei principi di giustizia e sulle basi normative del giudizio, cadono nell’errore opposto: prescindono dalla considerazione di rapporti sociali effettivi e sottovalutano i rapporti di forza.
Qui tocchiamo il nocciolo della nozione di ágalma: essa fa valere l’esigenza normativa, ma non la pensa in termini metafisici o morali come “valore”, bensì come prova di grandezza. L’aspetto estetico e simbolico della domanda di apprezzamento è strettamente connesso a quello sociale e politico: tuttavia qui interviene un elemento essenziale che è stato trascurato da Boltanski e Chiapello, la sfida. La prova di grandezza non può essere soltanto l’esecuzione corretta di un compito, fondata sul rispetto delle regole: in ciò non c’è nulla di grande! Non a caso coloro che, come Tommaso d’Aquino, hanno considerato la magnificenza come una virtù, l’hanno pensata come una parte del coraggio (fortitudo), insieme alla fiducia, alla pazienza e alla perseveranza (Maclaren 2002); in Boltanski e Chiapello opera una normalizzazione della grandezza, che è proprio contraria alla polemica contro il riduzionismo che essi sostengono. Ciò risulta dall’approfondimento della stessa nozione di prova.
Giustamente i nostri autori rifiutano ogni forma di determinismo storico, che pensa il processo storico come un corso impersonale e fatale. Le prove costituiscono proprio il momento critico in cui avviene qualcosa il cui esito è incerto: “la nozione di prova rompe con una concezione strettamente deterministica del sociale, sia che questa si fondi sulla onnipotenza delle strutture, sia – come nell’ottica culturalista – sul dominio delle norme interiorizzate” (Boltanski, Chiapello 1999: 73). Proprio a causa del pericolo che è implicito nella stessa idea di prova, molti hanno interesse ad aggirarla, operando degli spostamenti (déplacements) grazie ai quali fanno valere la forza sul rispetto delle regole, oppure squalificando la stessa idea di prova con vari argomenti (che vanno dal cattivo uso della nozione di libertà al costo eccessivo del suo svolgimento). La tendenza ad aggirare le prove costituisce un aspetto costante dello spirito del capitalismo ed una delle principali fonti di profitto (si pensi alla delocalizzazione del lavoro in regioni in cui la mano d’opera è a buon mercato e in cui i diritti degli operai sono poco rispettati). Tuttavia, poiché il capitalismo non può sopravvivere senza la partecipazione attiva del più grande numero possibile di persone (come investitori, lavoratori o consumatori), senza l’esistenza dello stato e senza un miglioramento delle condizioni di vita dei più poveri, ne deriva che esso è costretto a rilegittimare le prove che esistevano nel passato o ad inventarne delle nuove. Tenendo presente che il mondo è una rete, occorre perciò “offrire dei punti d’appoggio per apprezzare e ordinare il valore relativo degli esseri in un tale mondo” (p. 230). In altre parole lo sviluppo del capitalismo connessionista dipende dalla formazione di una città per progetti che si sottometta ad un’esigenza di giustizia.
In questo modo la prova di grandezza, la giustificazione e la critica sono strettamente congiunte, al punto che sembra impossibile pensare l’una senza le altre. Tuttavia è proprio di una “prova di grandezza” che parlano i nostri autori, oppure di un esame scolastico o di una partita di football? Mi chiedo se l’esigenza del rispetto delle regole non faccia passare in second’ordine sia la difficoltà implicita nell’idea di prova, sia l’eccezionalità implicita nell’idea di grandezza. Se la prova sportiva costituisce un paradigma per quanto riguarda la giustizia della prova (p. 403), non altrettanto si può dire per quanto concerne la sua arditezza. La competizione svolta sulla base dell’esecuzione di un compito prestabilito costituisce un aspetto non indispensabile di una prova di grandezza, la quale aspira al carattere della unicità e dell’eccezionalità.
Ciò risulta particolarmente evidente nelle arti, nella letteratura, nella filosofia e in tutte le attività simboliche nelle quali l’elemento creativo gioca un ruolo determinante; ma, a ben vedere, vale anche per ogni specie di attività. Nathalie Heinich (1998b) ha visto nella trasgressione l’aspetto essenziale dell’arte degli ultimi cento anni. Purtroppo questa nozione resta troppo dialetticamente dipendente da ciò che nega: su di essa pesa ciò che Nietzsche chiamava la “malattia delle catene”, cioè la subordinazione indiretta rispetto al passato.
Il conflitto e la sfida
Ci si avvicina di più alla sostanza della prova di grandezza focalizzando l’attenzione sulla sfida che essa implica. A differenza della trasgressione, in cui l’elemento della riflessività non è rilevante, la sfida comporta una valutazione di se stessi e una ponderazione intorno alla simmetricità dei contendenti e alle possibilità di vittoria.
Attribuire alla sfida una importanza centrale nella prova di grandezza vuol dire abbandonare ogni concezione organicistica della società: fintanto che la società è pensata come un insieme completamente integrato e omogeneo, la prova di grandezza si configura come la mera esecuzione di un programma prestabilito. Una ragione non secondaria dell’attrazione esercitata dall’organicismo sociale è proprio di natura estetica: è sull’ideale dell’armonia e dello sviluppo biologico che si è modellato finora l’incontro tra studi culturali ed estetica. Ma accanto ad un’idea del bello come armonia, è sempre esistita in Occidente un‘idea strategica del bello come esperienza degli opposti (Eraclito), acutezza (Gracián) e sfida. È in questa seconda direzione che, a mio avviso, deve essere cercato l’incontro tra estetica e scienze sociali, anche perché questa è la dimensione estetica conforme allo spirito del terzo capitalismo.
Nell’attribuire all’esperienza del conflitto un ruolo decisivo confluiscono varie tradizioni teoriche.
Di fondamentale importanza è la riflessione filosofica intorno alla lotta come motore della storia, che si estende attraverso i secoli, da Machiavelli a Hobbes, da Hegel a Marx, da Clausewitz a Carl Schmitt. È significativo che le ultime manifestazioni di questa grande corrente si focalizzino sulla lotta per il riconoscimento intesa come l’aspetto su cui si struttura la vita individuale e collettiva (Honneth 1992): in questi sviluppi la lotta è intesa non tanto come volontà di abbassare e di sopprimere l’avversario, quanto come diritto al rispetto e alla considerazione. Viene inoltre in luce il passaggio dalla nozione di onore, legato ai modi di vita di differenti stati sociali, a quella di dignità, intesa come dimensione morale che inerisce ad ogni essere umano, e a quella di stima sociale, che implica sollecitudine personale e considerazione cognitiva. Ognuna di queste nozioni ha avuto un’interpretazione estetica: si pensi al ruolo dell’onore nella tragedia del Seicento, alle considerazioni di Schiller sul rapporto tra grazia e dignità o al nesso tra la stima e il modo in cui nella seconda metà dell’Ottocento viene rielaborata l’idea di genio. Tuttavia mi sembra che la moralizzazione cui viene sottoposta l’idea di lotta finisca per impigliare questa problematica in un nodo etico-giuridico in cui si discute più di diritti e di doveri che di prove e di sfide. Ne deriva un’immagine statica della società che è in contrasto sia con la dinamica dello sviluppo economico attuale, sia con l’energetismo che caratterizza la tradizione filosofica in cui tali sviluppi si pongono.
Anche la sociologia ha riflettuto sul problema del conflitto. Contro gli orientamenti organicisti e integrazionisti, dominanti nell’Ottocento, che culminano nelle teorie della comunità, agli inizi del Novecento Georg Simmel ha visto la vicenda storica come un conflitto continuo tra due principi metastorici opposti, individuati rispettivamente nella vita e nella forma. Come è risultato ancor più chiaramente dagli interpreti e continuatori di Simmel, il conflitto diventa una delle forme più dinamiche di integrazione sociale: se ogni interazione tra uomini è un’associazione, il conflitto non è soltanto dissolutivo, ma anche connettivo e unificante. Il difetto di questa acuta concezione del conflitto è che corre il rischio di chiuderlo nell’idea piuttosto riduttiva della polarità. Non a torto perciò la riflessione sociologica ha cercato di affinare i suoi strumenti teorici, distinguendo, per esempio, tra competizione e conflitto: la prima sarebbe continua, impersonale ed inconscia, mentre il secondo sarebbe intermittente, personale e cosciente. A differenza del conflitto, la competizione non implicherebbe necessariamente un contatto o una comunicazione diretta, e tantomeno quindi una polarità .
Tuttavia è la recente tradizione teorica dell’antropologia quella in cui il conflitto è stato oggetto della più attenta riflessione. Come è noto, con la Scuola di Manchester (Max Herman Gluckman) viene abbandonata la teoria dell’equilibrio sociale a favore di una concezione della vita collettiva che fa del conflitto e della sua composizione il perno intorno a cui ruota l’esperienza sociale. I modi di tale composizione possono essere divisi in due categorie fondamentali: quella che prevede il ricorso ad un terzo che risolve la controversia (sotto l’aspetto di giudice o di arbitro) e quella in cui invece le parti si fronteggiano in vario modo (dal duello alla negoziazione). Tale impostazione teorica resta tuttavia piuttosto astratta ed ideale, perché in realtà i conflitti si svolgono assai spesso attraverso il ricorso contemporaneo ad una molteplicità di mezzi, alcuni normativi, altri fattuali, alcuni legali, altri illegali, alcuni giuridici, altri psicologici e così via.
Una considerazione più concreta dei modi in cui si sviluppa il conflitto si deve ad un allievo della Scuola di Manchester, Frederick G. Bailey (1970), per il quale la lotta politica avviene per lo più nella confusione. È ingenuo pensare che la vita politica si svolga soltanto sulla base di prove legittime e controllate, come se fosse una gara sportiva: in realtà lo svolgimento di una competizione regolata non esclude una lotta più o meno aperta per decidere quale sistema di regole governerà in futuro la competizione stessa. Sotto questo aspetto per Bailey le rivoluzioni, cioè i cambiamenti delle regole, costituiscono solo il punto di arrivo visibile di un periodo di infrazioni pragmatiche delle regole del gioco precedente. La lotta politica è perciò un misto di sfide e di scontri: le prime sono paragonabili a confronti a distanza nei quali si comunica all’avversario un mutamento relativo al controllo delle risorse e al credito politico; i secondi costituiscono invece la verifica degli effettivi rapporti di forza. La sfida sarebbe dunque ciò che Boltanski e Chiapello chiamano la critica rivoluzionaria, cioè il riferimento ad un’altra città politica.
Oltre alle prospettive filosofiche, sociologiche e antropologiche del conflitto c’è una quarta problematica del conflitto che definirei come “estetica”. Essa è particolarmente importante perché è proprio quella che, secondo Boltanski e Chiapello, è stata inglobata e ricuperata dallo spirito più recente del capitalismo. Sebbene le origini dell’estetica della lotta affondino le proprie radici nell’antichità e nel Barocco, è a cavallo tra Settecento ed Ottocento che essa si configura come un fenomeno socio-culturale dotato di una identità specifica: tale è appunto il dandismo, che non può essere considerato semplicemente come una forma di estetismo, ma implica l’adozione di strategie paradossali anomale rispetto a quelle economiche e politiche consuete. Il terreno su cui si svolge l’attività del dandy è appunto quello della vita quotidiana, che Baudelaire chiamava la vie moderne.
Ma nei confronti della nozione sociologica di “vita quotidiana”, che si regge sulla contrapposizione rispetto al lavoro, il dandy si pone in modo alternativo, proprio perché pretende di far saltare la separazione tra la professione e l’insieme delle altre attività. Il quotidiano diventa il luogo del suo massimo impegno, l’ambito in cui si pone la questione della grandezza e del riconoscimento: esso perciò viene sottratto sia alla routine abitudinaria sia alla mera ricreazione. Sotto un certo aspetto il dandy è il rivoluzionario del quotidiano: come è stato detto, il dandismo traspone l’eroismo della scena pubblica alla scena privata (Coblence 1988: 240). La sua ricerca della grandezza non passa attraverso la pratica di un’arte o di una scienza, né attraverso l’esercizio di un’attività che mira al raggiungimento del potere o della ricchezza, ma attraverso la sua capacità di suscitare stupore e ammirazione.
Le nozioni di sfida, prova e scontro su cui si costruisce la grandezza politica sono inadeguate a descrivere la grandezza del dandy. Certamente è essenziale al dandismo l’invito al confronto, ma esso più che una sfida, si potrebbe meglio definire come una provocazione. Infatti esso non si immagina il conflitto come una specie di duello tra entità opposte simmetriche, e neanche come l’appello ad un nuovo sistema di norme che regoli in futuro la competizione. Il dandy si pone fin da principio su un terreno differente da quello su cui sta l’avversario e su cui egli intende rimanere: tra se stesso e l’avversario pone una radicale dissimetria, come quella esistente per esempio tra la coscienza e l’inconscio. Nella provocazione ciò che è importante è proprio l’effetto perturbante di spaesamento; questo si ottiene facendo appello a qualcosa che è rimasto latente nell’avversario e che egli non può manifestare senza che la sua forza sia distrutta. Perciò esiste nella provocazione una dimensione erotica. Ma il dandy è qualcosa di più complesso di un libertino. Infatti accanto alla provocazione non meno importante è la prova. Questa tuttavia non deve essere intesa come un esame, ma come un’esperienza pericolosa cui ci si sottopone. Nelle lingue moderne il termine prova contiene entrambe le accezioni. Nel greco antico ci sono invece due parole distinte. Per l’esame si dice dokimasía; per l’esperienza si dice peîra. Nelle opere di Luc Boltanski la parola épreuve ha entrambi i significati. Tuttavia nel volume De la justification il riferimento agli autori principali della tradizione giansenistica (Agostino, Pascal, Nicole) conferisce alla parola una sfumatura religiosa, che è peraltro evidente nello stesso titolo dell’opera.
La prova cui si sottopone il dandy è un’esperienza di esteriorizzazione radicale, un annullamento della soggettività, che si manifesta nell’enorme importanza attribuita all’apparenza. Il culto dell’abito non è vanità, ma nasce da una precisa scelta teorica che gli impedisce ogni riferimento alla trascendenza, all’interiorità, ad una autenticità che sta oltre la città dell’opinione e della rinomanza: il terreno su cui si pone il dandy è quello del mondo. Ma in questo egli segue una strategia paradossale, una specie di politica dell’impossibile, che fa leva sull’imprevisto, sullo choc, sulle occulte complicità che può suscitare. In altre parole ciò che fa il dandy è la volontà di vincere senza ricorrere ai mezzi che sembrano più ovvii per ottenere il successo. Il dandy è uno che scommette sulla differenza e imprevedibilità del processo storico. Il risultato finale non è del resto l’essenziale; come per il saggio stoico e per il santo, dei quali egli è l’erede, la realizzazione dello scopo è incerta, ma non incerto è il conseguimento del fine. La prova perciò non deve essere intesa come un sacrificio di sé che trae il suo senso solo dal raggiungimento di uno scopo, in altre parole come un lavoro. L’esteriorizzazione radicale, il farsi abito ha il suo fine in se stesso e costituisce la provocazione essenziale. Suona come un annuncio di questo tipo: “io, che sono un marginale e un declassato, nella mia lotta contro di voi non mi appello ad un qualche principio morale o giuridico o religioso – di cui so benissimo che voi vi fate un baffo – ma combatto sul vostro terreno con delle armi e con delle strategie differenti dalle vostre. Nella misura in cui colpisco le vostre immaginazioni, il mio risultato è già raggiunto. E posso colpire le vostre immaginazioni proprio perché aspiro alla grandezza senza invocare nessuna trascendenza”.
Oltre alle provocazioni e alle prove, c’è un terza caratteristica che costituisce la figura del dandy. Mentre un aspetto importante della dinamica politica è rappresentata dallo scontro, che si configura come una verifica degli effettivi rapporti di forza, al dandismo invece appartiene una scelta opposta: il distacco, la sospensione, l’epoché. Il farsi nulla e nessuno, il coltivare un rapporto di profonda connivenza con la morte, lo spingere l’esteriorità fino alla sua massima manifestazione che è appunto il cadavere. Come è stato osservato uno dei principi del dandismo suona così: “In società, finché non avete fatto effetto, rimaneteci, prodotto l’effetto andatevene”. Il distacco tuttavia non deve essere inteso soltanto come un espediente psicagogico, un mezzo per far colpo sugli altri. Esso implica un lungo esercizio su se stessi, un’ascesi, che renda padroni di se stessi e capaci di dominare le proprie passioni. La premessa fondamentale di ogni dandismo è il raggiungimento dello stato di indifferenza, che tuttavia non vuol dire affatto insensibilità; esso al contrario ci apre su un altro tipo di sensibilità caratterizzata da una partecipazione impartecipe, da un “sentire dal di fuori”, da un misto di ardore e di gelo, che è in fondo il segreto di ogni grandezza.
Provocazioni, prove e distacchi delineano una fenomenologia dell’osare, nella quale ciò che importa non è la sfrontatezza e l’impudenza vitalistica, e nemmeno la scelta e la decisione morale, quanto l’aver fiducia in se stessi, l’essere selfconfident, la certezza di riuscire a cavarsela attraverso una rivalità mimetica con l’esteriorità più scorante, così come essa si manifesta nel sesso, nel denaro e nella morte. Entriamo così in territorio che è del tutto estraneo al vitalismo partecipazionista e comunicativo della contestazione artistica non meno che al modo in cui il terzo spirito del capitalismo vuole presentarsi. Le richieste di spontaneità, di autenticità e di liberazione su cui si reggeva la critica artistica alla società borghese non hanno niente che fare con lo spirito del dandismo, il quale ha invece un rapporto profondo con l’artificiale, con l’inorganico, con la ripetizione, con l’autocontrollo.
È necessario distinguere l’ideologia del terzo spirito del capitalismo dalla teoria critica di esso. L’ideologia ruota intorno alla soddisfazione della domanda di vitalità, autenticità, creatività, autonomia e liberazione: il grande rilancio del capitalismo a partire dagli anni Ottanta si fonda proprio sulla mercificazione di tale domanda, per esempio mediante la fornitura di prodotti ecologici o il diffondersi degli sport estremi, mediante l’offerta del turismo di sopravvivenza o di oggetti definiti come “graffianti, “eccitanti”, “audaci”. Uno studio della pubblicità degli ultimi dieci anni mostra l’emergenza di uno stile (come dicono i francesi) accro, cioè basato sul culto della performance e dell’estremo, in cui si propone a tutti di trasformarsi nell’eroe o nell’eroina capace di vivere in un rapporto appassionato col mondo mediante il consumo di una determinata merce: per esempio, il messaggio pubblicitario “l’aria è vinta e rinuncia a resistere” è la pubblicità di una moto; “rischiare la morte è la bella vita” quella di una marca di champagne (Baudry 1991). Per questa ideologia il nemico da battere è la standardizzazione, l’omogeneizzazione, la noia di cui è intessuta la vita quotidiana. Essa quindi fa proprio quel progetto di “rivoluzione della vita quotidiana” che i poeti e gli artisti hanno coltivato a partire dallo Sturm und Drang, cioè dall’epoca del primo capitalismo, fino ai Surrealisti e ai Situazionisti (Lefebvre 1958-61; Perniola 1998). Questa appropriazione è tuttavia ovviamente anche uno svilimento, una degradazione perché in tutto ciò che propone il terzo spirito del capitalismo c’è ben poco di veramente liberatorio e creativo.
La teoria critica ha perciò già dagli anni Sessanta seguito una strada opposta: quella della decostruzione dell’autenticità. Già lo strutturalismo e la semiotica hanno screditato il vitalismo e il pathos ontologico. Infatti l’affermazione del primato della struttura e del codice fanno saltare la possibilità di riferirsi ad una presenza originaria ed autentica. L’opera di Jacques Derrida, affermando l’egemonia della scrittura sulla voce, ha reso impossibile ogni ricaduta nella metafisica. Gilles Deleuze, radicalizzando la critica al platonismo, ha riabilitato le copie rispetto agli originali. Questa decostruzione ha trovato un alleato nelle ricerche sociologiche più recenti, che studiano le forme simboliche evitando di cadere sia nel riduzionismo che nell’essenzialismo. Ora questa decostruzione ha corso il rischio di cadere in un nichilismo disperante; ma esso è solo l’altra faccia della metafisica, un restare in lutto per la morte di Dio invece di comprendere i complessi e sottili dispositivi attraverso i quali le forme simboliche si costituiscono, si mantengono e deperiscono. Non abbiamo bisogno del pathos della catastrofe o di un’estetica del terrore, ma di un pensiero coraggioso che sappia porre la questione della grandezza in alternativa alla questione della forza, senza appellarsi ad entità trascendenti o valori che si sono rivelati molto più deboli del pensiero che ironicamente si definiva debole.
di Mario Perniola
Bibliografia
Bailey, F. G.
1970 Stratagems and Spoils. A Social Anthropologie of Politics, Oxford, Basil Blackwell; trad. it. Per forza o per frode, Roma, Officina, 1975.
Barbey D’Aurevilly, J.
1845 Du Dandysmpe et de Georges Brummell, in Oeuvres Romanesques Complètes, Paris, Gallimard, 1964-66; trad. it. Lord Brummell e il dandismo, Palermo, Sellerio, 1981.
Bataille, G.
1949 La parte maudite, in Oeuvres complètes, vol. VII, Paris, Gallimard, 1970-88.
Baudrillard, J.
1968 Le systhème des objets, Paris, Gallimard.
Baudry, P.
1994 Superspeed, in Perniola 1994, pp. 16-22.
Boltanski, L. – Chiapello, È.
1999 Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Boltanski, L. – Thévenot, L.
1991 De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.
Clifford, J.
1988 The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, Art, Berkeley, University of California Press; trad. it. I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura ed arte nel secolo XX, Torino, Bollati Borighieri, 1998.
Coblence, F.
1988 Le dandysme, obligation d’incertitude, Paris, P.U.F.
Connor, S.
1992 Theory and Cultural Value, London, Blackwell.
Coser, L. A.
1956 The function of Social Conflict, New York, The Free Press; trad. it. Le funzioni del conflitto sociale, Milano, Feltrinelli, 1967.
Dorfles, G.
1988 Il feticcio quotidiano, Milano, Feltrinelli.
Eagleton, T.
1990 The Ideology of the Aesthetic, London, Blackwell.
Elias, N.
1939 Über den Prozess der Zivilisation, Basilea, Haus zum Fackel; trad. it. Il processo di civilizzazione, Bologna, Il Mulino, 1988.
Ferry, L.
1990 Homo Aestheticus, Paris, Editions Grasset & Fasquelle; trad. it. Homo Aestheticus. L’invenzione del gusto nell’età della democrazia, Genova, Costa & Nolan, 1990.
Frow, J.
1995 Cultural Studies and Cultural Value, Oxford, Clarendon Press.
Gernet, L.
1948 La notion mythique de la valeur en Grèce, in Anthropologie de la Grèce ancienne, Paris, Maspero, 1968; trad. it. Antropologia della Grecia antica, Milano, Mondadori, 1978.
Haug, W. F.
1971 Kritik des Warenaesthetik, Frankfurt a.M., Suhrkamp.
Heinich, N.
1990 La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, Minuit.
1998a Ce que l’art fait à la sociologie, Paris, Minuit.
1998b Le triple jeu de l’art contemporain, Paris, Minuit.
Honneth, A.
1992 Kampf um Anerkennung, Frankfurt a.M., Suhrkamp.
Kerényi, K.
1962 Agalma, Eikon, Eidolon, trad. it. in Scritti italiani (1955-1971), a cura di G. Moretti, Napoli, Guida, 1993.
Lefebvre, H.
1958-61 Critique de la vie quotidienne, 2 voll., Paris, L’Arche.
Maclaren, S.
2002 Lusso, spreco, magnificenza, “Ágalma”, n. 2, pp. 43-62.
Mauss, M.
1924 Essai sur le don, in Oeuvres, Paris, Minuit, 1968.
Milner, J.-C.
1997 Le salaire de l’idéal. La théorie des classes et de la culture au XX siècle, Paris, Seuil.
Perniola, M.
1971 L’alienazione artistica, Milano, Mursia.
1980 La società dei simulacri, Bologna, Cappelli.
1982 Dopo Heidegger. Filosofia ed organizzazione della cultura, Milano, Feltrinelli.
1994 a cura, L’aria si fa tesa, Genova, Costa & Nolan.
1998 I situazionisti, Roma, Castelvecchi.
Simmel, G.
1918 Der Konflict der modernen Kultur. Ein Vortrag, Münich/Leipzig, Dunckler & Humblot.
Vennaven, S.
1994 Osare, in Perniola 1994, pp. 16-22.
Veyne, P.
1976 Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Editions du Seuil; trad. it. Il pane e il circo. Sociologia storica e pluralismo politico, Bologna, Il Mulino, 1984.
Weber, M.
1920 Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen, Mohr; trad. it. L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Firenze, Sansoni, 1977.