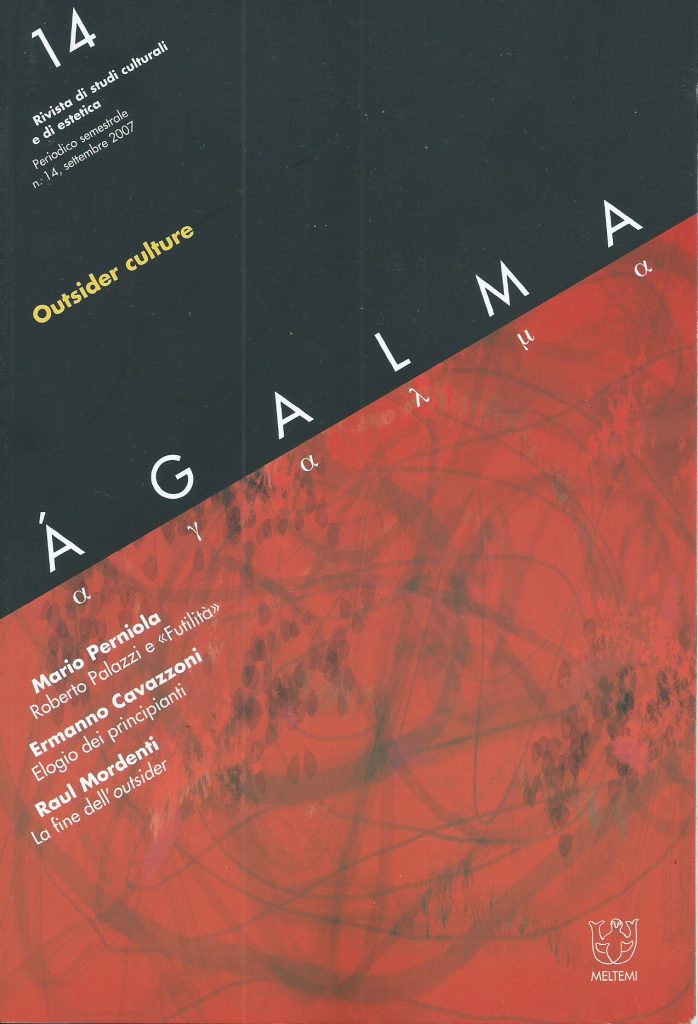René Capovin – La parola “outsiders” esiste
Per gli scommettitori è facile, “outsiders” è un termine tecnico che designa le sorprese attese: le squadre non favorite ma comunque non escluse dai pronostici, i cavalli un po’ stracchi o troppo giovani che però ce la potrebbero anche fare a piazzarsi, il ciclista che se non piove e non fa freddo in salita va come un treno etc. I professori universitari a volte non conoscono la parola, ma è raro non ne abbiano sperimentato un suo significato: nel loro caso, “outsiders” indica gli studiosi dilettanti che alle conferenze fanno domande troppo difficili, gli esegeti in proprio del pensiero marxiano o della civiltà indiana che a volte paiono saperne più di Balibar o di Dumont.
Se poi vogliamo focalizzarci, come nel nostro caso, sul significato di “outsiders” per chi studia la società, entriamo in acque dai moti ondosi particolarmente accentuati. Si tratta di una parola-chiave, certamente, e come tutte le parole-chiave appare fortemente equivoca. Cavalcando l’onda del classico Outsiders di Howard S. Becker, cercheremo di capire perché questa parola sia così decisiva, prendendo in esame anche declinazioni meno classiche ma più rivelatrici della sua attuale vita sociale1.
Devianti e no
Se una specifica elaborazione del problema della doppia contingenza deve accompagnare qualsiasi lavoro che si voglia “sociologico”2, il lavoro di Becker è classicamente sociologico.
Dire che l’interazione sociale è una struttura a doppia contingenza significa dire che l’esito dell’azione non dipende soltanto dalla scelta (contingente) di Ego, ma anche dalla reazione (contingente) di Alter all’azione di Ego: “essere inseriti in una struttura a doppia contingenza vuol dire – in primo luogo – che l’esito dell’interazione dipende dalla capacità di Ego di prefigurarsi le possibili risposte di Alter ai propri atti e agire di conseguenza” (Sciortino 1998, p. 110).
Becker non fa che estendere questa problematica alla genesi e all’applicazione della parola “outsiders”. Il termine ha corso in particolari casi di interazione a doppia contingenza, resistenti (almeno in apparenza) alla stabilizzazione: “Quando una norma è imposta, la persona che si presume l’abbia infranta può essere vista come un individuo particolare, che non si può essere sicuri viva secondo le regole concordate dal gruppo. Tale tipo di persona è considerato come un outsider” (Becker 1963, p. 21). Così, se una “base condivisa di ordine normativo” (Parsons 1968, p. 168) è la condizione (1) per rendere intelligibile l’azione altrui e (2) per stabilizzare l’interazione e renderla relativamente immune ai fallimenti (cfr. Sciortino 1998, p. 114), l’outsider sarà colui cui viene imputata la deviazione sistematica rispetto a questi criteri normativi condivisi. Così, se il concetto di “norma” è lo strumento di lavoro fondamentale della sociologia da cui Becker si distingue (e, così facendo, ribadisce) (3), la devianza non è che l’altro lato di questo concetto – e per questo osservare gli outsiders, in quanto portatori di devianza, significa anche osservare la società nel suo insieme (4).
Ora, la parola “outsiders” non si limita a indicare la presenza di un problema di coordinamento delle interazioni (5): è anche un modo per risolverlo. Il lavoro sociale della parola “outsiders” sta proprio nel riunire in un’unica classe individui dal comportamento deviante, standardizzandoli e rendendoli così prevedibili. Il punto su cui Becker attira l’attenzione è che, come tutte le azioni, anche l’atto del classificare si colloca entro una struttura a doppia contingenza: “la persona cui viene attribuita l’etichetta di outsider può avere un altro punto di vista sulla questione. Può non accettare la norma in base alla quale è giudicata, e non ritenere coloro che la giudicano competenti o legittimamente qualificati a farlo. Emerge allora un secondo significato del termine: il trasgressore della norma può considerare i suoi giudici come outsiders” (p. 21). Nei termini sociologici che stiamo usando, Becker dice qui un’ovvietà, solo che la riferisce a un tabù: che Alter possa agire in maniera non corrispondente alle attese di Ego è il primo problema che sorge se si guarda il mondo con occhi sociologici; il fatto è che questa prospettiva non viene estesa all’atto del classificare. Questo processo può essere denominato “naturalizzazione dell’outsider”: come classificare un quark come “quark” non fa differenza per il quark (6), così si assume che classificare un outsider come “outsider” non faccia differenza per l’outsider.
Nella sua denaturalizzazione del genere “outsiders”, invece, Becker non smette di sottolineare come si debba tener sempre ben presente che le persone agiscono insieme, che “fanno ciò che fanno con un occhio su ciò che gli altri hanno fatto, stanno facendo e possono fare in futuro” (p. 180), e che l’etichettare, così come l’essere e il sentirsi etichettati, sono dimensioni essenziali di questo gioco di reciprocità. Ciò conduce a trattare “outsiders” come un genere interattivo: si tratta di una di quelle classificazioni che, “quando vengono conosciute dalle persone o da coloro che le circondano, e vengono fatte agire nelle istituzioni, cambiano i modi in cui gli individui esperiscono se stessi – e possono persino condurre i soggetti a mutare i loro sentimenti e il loro comportamento, in parte perché sono così classificati” (Hacking 1999, p. 94). Così, se vogliamo davvero analizzare un episodio di presunta devianza, dobbiamo osservare tutte le persone coinvolte, e considerare tutto quello che fanno – anche quando classificano! Solo così rendiamo giustizia al fatto che le persone tengono conto del modo in cui le altre persone coinvolte valuteranno la loro azione e di come tale valutazione inciderà sul loro prestigio e sul loro rango (Becker 1963, p. 181).
Abbiamo detto che non considerare la classificazione come un’azione sociale trasforma gli outsiders in un genere non interattivo. Corollario necessario di questa operazione è l’oscuramento del classificatore: “Ciò che un profano vuole sapere sui devianti è: perché lo fanno?” (p. 23). Per il senso comune, infatti, si tratta solo di capire perché i trasgressori trasgrediscono – che le norme siano valide non è mai messo in questione. Così, quando lo scienziato acritico prende i devianti, e quindi le norme, per dati di fatto, e cerca di fornire un qualche tipo di “spiegazione”, egli non fa che accettare “i valori del gruppo che emette il giudizio” (ibid.).
Becker non intende produrre una contro-teoria della devianza. Quelle che vengono presentate sono delle incursioni etnografiche in mondi devianti (in particolare, consumatori di marijuana e musicisti di musica da ballo), in relazione alle quali le riflessioni appena riproposte costituiscono la necessaria, ma non troppo impegnata, cornice di legittimazione. Dal punto di vista operativo, Becker costruisce una specie di “quadrato della devianza” (7). Procede così: prende due schemi binari (compimento o non compimento di un atto potenzialmente deviante; percezione o non percezione di tale atto come deviante), li incrocia e ottiene quattro tipi di comportamenti: conforme (chi non compie l’atto e non viene percepito come deviante); falsamente accusato (chi non lo compie ma viene percepito come deviante); pienamente deviante (chi compie un atto potenzialmente deviante e viene percepito come deviante); segretamente deviante (chi compie l’atto ma non viene percepito come deviante). Ora, se integriamo tali coordinate con la variabile-tempo otteniamo lo strumento fondamentale messo a punto da Becker, cioè un modello sequenziale per ricostruire la vita sociale dell’outsider (8) : “La devianza non è una semplice qualità, presente in certi tipi di comportamento e assente in altri, ma è piuttosto il prodotto di un processo che implica le reazioni di altre persone a un determinato comportamento” (p. 36), comportamenti e reazioni che devono essere scanditi in stadi distinti. La nozione di “carriera deviante” indica appunto l’esistenza di incroci tra condizioni oggettive e scelte individuali. Tale prospettiva evidenzia la contingenza della condizione di chi conduce un’esistenza radicalmente deviante e rende conto dei casi di devianza transitoria, per esempio quei giovani delinquenti che a un certo punto cambiano vita (Becker 1963, p. 42).
Il lavoro di Becker ha il merito fondamentale di gettare luce sull’intrinseca riflessività della categoria di “outsiders”: chi considera l’altro un “outsider” può essere giudicato dall’altro come un “outsider”. La reciprocità del giudizio di “essere outsiders” non significa affatto che le due categorie si trovino sullo stesso piano: entro la processualità della classificazione reciproca agisce un’asimmetria reale che inchioda i veri outsiders, cioè i veri devianti. Questo aspetto è piuttosto ovvio ma va sottolineato: se osserviamo meglio i due punti di vista, ci accorgiamo che ciò che li separa è un dislivello di potere – c’è una parte che esercita potere e un’altra che lo subisce, e il fatto che per questi ultimi siano gli altri a risultare outsiders non ha effetti reali. Insomma, basta guardare cosa dicono le leggi e cosa fa la polizia per capire chi sono i veri devianti. Viceversa, basta guardare chi fa le leggi e chi le fa applicare per capire chi tiene il coltello dalla parte del manico. Becker si sofferma sulla categoria degli “imprenditori morali”, quei tipici “crociati delle riforme” che si fissano su un problema, fanno una campagna, creano una nuova legge e con essa “un nuovo gruppo di outsiders” (p. 157).
In questi passaggi, che costituiscono forse il vertice polemico del libro, sembra aprirsi lo spazio per un’immediata obiezione “realista”: sarà pure costruito l’outsider, ma “quelli che fanno così” (che fanno gli ultras (9), che rubano (10), che abusano dei bambini (11), etc.) ci sono davvero. Con quelli come la mettiamo? Hai voglia a decostruire e a relativizzare… Questo tipo di rilievi presuppone una controparte che asserisca una tesi iper-costruttivista secondo cui, in realtà, non ci sono “cose”, ma solo nomi. Ebbene, vale la pena sottolineare che Becker non dice questo (12) (nessuno, che io sappia, dice esattamente questo), e comunque non occorre sollevare una tesi così forte per mantenere il punto del “lavoro sociale” svolto dall’incasellare individui in “generi”. Certamente, stabilire il livello oltre il quale una puntualizzazione sociologica delle tappe di questo processo diventa inutile o banale è questione decisiva, ma tale questione sorge solo dopo che si sia riconosciuta la rilevanza del modo (vischioso ma contingente e, in certa misura, reversibile) in cui la realtà sociale viene ritagliata.
L’atto puntuale della trasgressione diventa così la trama di un vero e proprio romanzo sociale, cui prendono parte i trasgressori, i rappresentanti della legge e della moralità, i giudici, ma anche attanti (13) come il mutamento delle norme (formali e informali), le eccezioni nell’applicazione delle pene, le zone franche ecc. Insomma, l’analisi della vita sociale della parola “outsiders” è un gorgo in cui viene trascinata l’intera società, e ciò perché tutta la società contribuisce alla vita dell’ordine normativo. Nondimeno, anche questa somma prova di visione periferica (14) sembra avere delle zone d’ombra.
La maggioranza silenziosa
Il grande interesse della parte etnografica del libro di Becker sta nel farci vedere le cose da una prospettiva rovesciata: sentiamo parlare le persone di cui di solito si parla, e li sentiamo parlare di quelli che di solito parlano di loro. Peraltro, all’interno di questa dialettica di azioni e reazioni viene lasciata in secondo piano quella vastissima zona grigia costituita da coloro che, nello schema quadripartito di Becker, sono etichettati come “conformi”. Si tratta di quegli individui che non sono devianti ma (questo il punto che si vuole sottolineare) non è detto siano degli imprenditori morali o dei loro sostenitori: i conformi seguono le norme ma (forse, chi lo sa) più per inerzia che per convinzione. In altri termini, la tesi qui avanzata è che tale rovesciamento dia i frutti migliori quando si tratta di rintracciare, sotto la maschera della conformità, il comportamento segretamente deviante, i piccoli affari sporchi che tanti fanno ma nessuno dice. Questa prospettiva, però, se pure crea lo spazio logico per situare il comportamento “conforme”, cioè quello di chi non commette atti potenzialmente devianti né viene accusato di averli commessi, ha il difetto di scambiare spesso (15) tali individui per sostenitori attivi dell’ordine normativo esistente. Quella che pare essere postulata, così, è una continuità reale che unisce conformi a imprenditori morali.
La legittimità di questa connessione apparirebbe, con ogni probabilità, molto meno ovvia, se solo si ascoltassero i “conformi” con la stessa attenzione con cui Becker ascolta i “devianti”. Qui ci si focalizzerà su un caso di conformità che Becker non considera: capire i motivi di questa mancata messa a fuoco ci aiuterà a chiarire i limiti della nozione di devianza in esame.
Il caso è quello dell’immigrato in Italia e della sua costruzione sociale. Si tratta di un grande produttore di atti potenzialmente devianti: parlatore di lingue che non sono il dialetto degli indigeni e nemmeno l’italiano, generatore di figli rumorosi, cucinatore di fritti nauseabondi, alitatore di aglio ecc. Anche qui, hai voglia a relativizzare… Abbiamo visto sopra come vanno le cose. L’indigeno qualunque si chiede: “perché lo fanno?”, e lo scienziato acritico (ma anche e soprattutto il politico, il giornalista, l’amministratore locale ecc.) cercherà di produrre risposte. Tra queste, spicca la tautologia: “Perché non conoscono la nostra cultura”. Una delle nuove configurazioni dell’imprenditore morale sta proprio nel definire cosa sia la nostra cultura e nel rendere tale definizione operativa. Di solito si comincia dal facile: per prima cosa, la lingua nazionale (peraltro in Italia spesso non necessaria, addirittura escludente in Veneto, che è l’unica Italia che conosco un po’, non da ultimo perché ne parlo il dialetto; e infatti non manca chi chiede l’insegnamento del dialetto a scuola).
Poi i nostri simboli, le nostre radici, i nostri valori (nell’attesa di metterci d’accordo, si è partiti dall’imposizione dell’inno, che adesso un po’ tutti devono dimostrare di sapere e di cantare – durissime reprimende al calciatore oriundo argentino che si ostina a non gridare “stringiamoci a coorte”). Osservando questi episodi si ha spesso l’impressione che qui il principio di ragione, secondo cui ogni cosa deve avere una ragione, un fondamento, non valga: se c’è devianza, ci si dice, ci dovrà pur essere una norma… Eppure, in tutta una serie di ambiti quotidiani, le ricostruzioni proposte appaiono vere e proprie proiezioni normative, bene-o-male intenzionate, in ogni caso scollegate dal livello da cui eravamo partiti, in cui l’intrico di specifiche, sottintesi e adattamenti sembra rendere insensata l’idea stessa di un corso d’azione medio e determinato (16).
Ora, il carattere immaginario di queste costruzioni (che certo, possono essere “decostruite”, anche se con effetti quasi sempre trascurabili) si situa su un piano diverso rispetto a quello in cui emerge il carattere perturbante o, più banalmente, fastidioso (17) della lingua ignota, dei rumori, degli odori e della diversità di abitudini. Se si ammette questa distinzione, possiamo sostenere che il quotidiano in cui avviene la registrazione di questi particolari atti devianti non trasforma automaticamente chi registra in un “conforme” impegnato, né lo porrà necessariamente sulla difensiva. La semplice registrazione della devianza è spesso occasione per “vedere” la nostra cultura (non necessariamente con occhi benevoli!) e per lasciare libero corso a ibridazioni, incroci, scambi ecc. Se, una volta tanto, guardiamo anche alla “cultura conviviale” (18) che in questo spessore interattivo lasco può svilupparsi, forse possiamo uscire dall’idea che l’unico senso sociale dell’agire sia riconducibile all’osservanza o meno della norma: invece di restare lì a guardarsi in cagnesco e a etichettarsi, individui con lingue, odori e abitudini diverse possono anche trovare il modo di vivere insieme (19).
Il tendenziale appiattimento del “conforme” sul “convinto” fa emergere un tratto decisivo dell’impostazione di Becker: la devianza al centro della sua analisi è quella che implica un conflitto conclamato e protratto nel tempo. Potremmo dire che, come si parla di una relazione tramite danaro (cash nexus) per la rivoluzione industriale, come si parla di “relazione tramite il pane (bread nexus) per il secolo XVIII, in cui “il conflitto tra campagna e città si manifestava sul problema del prezzo del pane e quello tra tradizionalismo e nuova politica economica era incentrata sulle Leggi del grano” (Thompson 1981, p. 386), così potremmo parlare di relazione tramite la devianza per il mondo inferibile dal libro di Becker. Da una parte chi fa le norme, dall’altra chi le disfa; di qua gli imprenditori morali, rappresentanti (o presunti tali) del popolo dei non-devianti, dall’altra i devianti, marcatori ambulanti dei confini della “società buona”.
Non è un caso che l’imprenditore morale sia visto da Becker principalmente come il “crociato delle riforme”, tutto teso a far approvare una “legge”: il codice del diritto, consentendo tutto ciò che non vieta, è proprio lo specchio magico che rende invisibili gli spazi in cui le persone possono “legarsi”, ponendo invece in primo piano gli spazi interdetti e le correlative trasgressioni. Viene così a delinearsi un mondo di guerre in trincea, la cui posta sta nella conquista di terreno che in sé non conta nulla, conta solo perché è occupato dall’altro – un conflitto inestinguibile, iper-riflessivo, che fa vedere in filigrana le coeve sperimentazioni tese ad affermare e coltivare la devianza in una logica del “conflitto per il conflitto” che, come vedremo, ricalca non solo nella formula la logica dell’’“arte per l’arte” (20).
Un mondo quasi perfetto
Al giorno d’oggi, nemmeno il deviante è più lo stesso. L’analisi del “nuovo spirito del capitalismo” offerta da Luc Boltanski e Ève Chiapello porta a chiedersi se il problema sia solo quello di riconoscerlo o se al suo posto ci sia un’altra persona.
Il capitalismo è un sistema che, a differenza dell’economia schiavistica, implica una sottomissione volontaria e necessita quindi di una giustificazione: “Lo spirito del capitalismo non è perciò una sovrastruttura, ma gioca un ruolo centrale nella sua dinamica economica, la quale aspira alla legittimità” (Perniola 2002, p. 64). Così, a partire dagli anni Trenta del Novecento, il capitalismo delineato da Weber ha dovuto reinventarsi per rispondere alla critica del movimento socialista e operaio: è l’epoca della grande impresa industriale, centralizzata e burocratica, dei sindacati forti, del posto fisso, della competenza professionale riconosciuta. Negli anni Sessanta e Settanta, il gioco al rialzo di questo tipo di critica sociale si compone con la critique artiste, che solleva richieste di autonomia, di creatività, di autenticità e di liberazione fino ad allora sostenuti dagli ambienti artistici e letterari, ma in quel momento storico capaci di ottenere un’adesione di massa. Negli anni Ottanta il capitalismo tende a fare proprie queste rivendicazioni di carattere estetico e nasce il “terzo spirito del capitalismo”. Per questo motivo l’ideologia del capitalismo contemporaneo si fa beffe dei movimenti o delle teorie classicamente “oppositive”: “Il manager creativo si pone come l’erede dell’artista bohemien: le esperienze maturate in ambiti marginali, trasgressivi o rivoluzionari, sono ritenute molto utili ai fini dello sfruttamento capitalistico di settori non ancora o debolmente mercificati” (p. 65).
Ciò pare equivalere a un aggiornamento contenutistico di una forma concettuale che conosciamo bene: non è forse una nuova configurazione del rapporto tra devianti e no? Semplicemente, gli ex-portatori della critica alla società dei consumi (freak, gruppettari, estremisti vari) diventano i nuovi arbitri del trend, mentre quelli che erano conformi (sindacalizzati, familisti, sobri) necessitano di programmi di reinserimento sociale. Ora, che i devianti diventino imprenditori morali, ineffabili predicatori di “devianza cool”, che gli artisti si siano convertiti a manager senza nessuno sforzo (anzi, continuando a fare esattamente quello che facevano!) non dovrebbe sorprenderci più di tanto: semplicemente, la carriera deviante è diventata (per molti, anche se non per tutti) carriera perché… anche il mondo è cambiato, nel frattempo.
Non si tratta di militanti, ma di simpatizzanti della felicità e del successo. Generazione uscita dagli anni Sessanta e Settanta, ma affrancata da ogni nostalgia, da ogni cattiva coscienza, e perfino da ogni subcoscienza di questi anni folli. Ripulita delle ultime tracce di marginalità come da un’operazione di chirurgia estetica, volto nuovo, unghie nuove, neuroni tirati a lucido e software in ordine di combattimento (Baudrillard 1986, p. 122).
Secondo Boltanski e Chiapello, la pretesa di legittimità del capitalismo si articola su “prove” specifiche, che permettono di distinguere la fattualità dello sfruttamento da un ordine politico-economico giustificato. Queste prove sono ciò che una critica all’altezza dei tempi è chiamata a elaborare: il movimento operaio fiorito all’inizio del secolo e quello libertario esploso con il maggio ’68 si distinguono proprio per l’incidere in maniera diversa sui criteri che regolano queste prove di legittimità. Ora, il rilancio del capitalismo degli anni Ottanta si è accompagnato a una sconfitta della critica: per un verso, la critica sociale si è trovata davanti a cambiamenti che non ha saputo interpretare e contrastare in maniera efficace; dall’altro, i portatori della critica d’artista sono stati “soddisfatti dei cambiamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro e, più generalmente, della società” (Boltanski 2002, p. 18) (21). Per la critica si tratterebbe adesso di delineare nuove prove, prendere il capitalismo alla sprovvista e modificare a propria immagine l’ordine sociale.
Secondo Mario Perniola, la prova da sottoporre alla veste contemporanea del capitalismo deve essere cercata ancora entro l’ambito estetico, assumendo come modello non più la trasgressione dell’artista marginale, ma la condotta enigmatica del dandy. L’intento di Perniola consiste nel contrapporre al “vitalismo partecipazionista e comunicativo della contestazione artistica” (Perniola 2002, p. 77), fonte dell’ideologia del terzo spirito del capitalismo, l’algida figura di questo outsider “del terzo tipo” (cioè né deviante né imprenditore morale), che sfida l’ordine delle convenzioni ma dall’interno. Valutare compiutamente questa proposta (22) implicherebbe un discorso più articolato di quello che può essere qui condotto: ci si limiterà ad alcuni accenni, comunque necessari vista la rilevanza di questa tesi per il discorso che stiamo conducendo.
La storia della riflessione sul dandy ha una problematica quasi teologica: si tratta di una nozione non solo paradossale, ma per molti versi apertamente contraddittoria, sprovvista di effettivi “correlati reali” se si eccettua Lord Brummell, unico “vero” dandy – il dandysmo è, per molti versi, l’interpretazione della storia dei suoi atti e può essere visto come l’elaborazione di questa sorta di mistero laico fattosi veste. Il dandy si riconosce retrospettivamente, dai suoi effetti: cambia con le mode e con le circostanze, e a queste si adegua solo per usarle come fondale su cui far risaltare le “proprie” provocazioni. Le virgolette devono accompagnare ogni riferimento al “proprio”, all’“unico”, all’“autentico”, quando si parla del dandy: “la sua identità e la sua particolarità si costituiscono solo nel confronto con la prospettiva degli altri, dalla quale devia. Si tratta di pura esteriorità, senza un’autenticità di fondo a cui fare riferimento” (Esposito 2004, p. 124). La proposta di Perniola, però, sembra rendere questo modello non componibile con la nozione di “prova” e di “critica” usate da Boltanski e Chiapello, di cui dovrebbe essere un correttivo. Perniola chiama in causa il dandysmo per contrastare le derive proceduralistiche della nozione corrente di “prova” (23), ma lo fa in un modo che toglie alla “critica” che ne scaturirebbe il suo carattere essenziale: la possibilità di auto-legittimarsi. Se, con Boltanski, si ammette che il capitalismo deve essere stimolato verso nuove forme di legittimazione pubblicamente riconosciute, la critica che riesce a imporre queste nuove prove, per restare “critica”, deve essere in qualche modo legittimata. In questa luce, però, particolarmente problematici appaiono due dei tratti che individuano il dandy: l’origine del suo potere sociale e il suo essere selfconfident.
Anzitutto, per essere presi in contropiede dal dandy si deve aver primariconosciuto che la sua mossa merita una qualche attenzione: l’outsider deviante non gode di questa apertura di credito, è solo una fonte di fastidi da cui tenersi alla larga, mentre il dandy è cercato. Questa è una sorta di condizione sociale di possibilità del dandy, ed è una circostanza difficilmente producibile: Brummell rivendica l’origine plebea (24), ma lo fa davanti a un pubblico che pende dalle sue labbra. Se nessuna istanza merita questo credito, niente dandy e, quindi, niente prova. Una critica di questo tipo, peraltro, risulterebbe episodica e, soprattutto, non legittimabile: la performance del dandy “vale”, se e dove vale, soltanto perché vale – non c’è nessuna giustificazione sotto.
In secondo luogo, il dandy accetta senza problema di apparire talora come un perfetto idiota (Coblence 1988, p. 97). Il dandy, infatti, non è uno snob: non dipende dal giudizio altrui, non ha paura di apparire ridicolo, e questo perché il dandy, erede del saggio stoico e del santo, deve mantenersi indifferente all’esito delle sue provocazioni. Il dandy non vuole piacere, ma sorprendere: si regola sugli altri ma solo per affascinarli, per colpire la loro immaginazione. Ora, immaginiamo il caso di una persona che simuli sorpresa solo per non creare imbarazzo a colui che intendeva sorprenderlo – generalmente ogni festa, ogni convegno accademico, ogni ritualità ha il suo apprendista-dandy e colui che pazientemente se lo sciroppa. Questa scena disegna un problema rilevante per chi voglia proporre un riuso critico del dandysmo: qual è la “prova” che permette di capire se la provocazione è davvero tale? In fondo, ogni apparente conferma della propria efficacia potrebbe essere solo una gentile concessione dell’altra parte: essere selfconfident immunizza dal dubbio di essere del tutto ineffettuali (lo si è detto, il dandy sa di poter passare per un idiota) – ciò non toglie, però, che ineffettuali lo si possa essere davvero, e che porsi questo interrogativo, per una prospettiva critica, pare necessario (25).
L’importanza del poter non essere outsider
Forse proprio la difficoltà di configurare una prova all’altezza della “città per progetti” (26) può aiutarci a definire i limiti della forma devianza. In effetti, l’insostenibilità sociale di un capitalismo che valorizza la rete e il sapere non si vede guardando i devianti, ma gli esclusi: chi non è abbastanza connesso e non ha sufficiente istruzione, resta fuori. In questo caso, chi è out non ha fatto nulla di deviante: non si tratta più, come nello schema di Becker, di persone ingiustamente accusate per via di errori o pregiudizi, ma semmai di esclusi senza colpa. Così, se prima abbiamo toccato l’enigmaticità del conforme qualunque, che non devia dalle norme ma non è detto le abbia fatte proprie, ora va almeno indicato il dilemma (27) dell’escluso qualunque, che non trasgredisce nulla ma è in isolamento a tempo indeterminato.
Abbiamo visto che il lavoro di Becker, contestualizzando e temporalizzando la devianza, ha permesso di denaturalizzare il genere “outsiders”: si è outsider, ma si poteva anche non diventarlo se…; non si è outsider, ma si poteva anche diventarlo se… Quando si parla di “esclusi” il rischio è quello di ritornare a una visione statica, fissata dalla presa d’atto che vi sonoesclusi. La mossa corrispondente a quella di Becker consiste allora nel cogliere l’esclusione come un processo istituzionalizzato (28). In tal modo, possono essere indicate precise operazioni che concentrano individui in spazi sociali speciali, lasciano strati della popolazione al loro destino e/o attribuiscono “uno status sociale di semi-cittadinanza a particolari categorie della popolazione” (Prandini 1999, p. 158) (29). Ecco allora che devianti ed esclusi appaiono due modalità del genere “outsiders” nell’accezione qui ricostruita: anche gli esclusi, come i devianti, sono “outsiders” a condizione di essere denaturalizzati e considerati secondo un’ottica processuale. Si dice outsider, ma si può leggere relatività, o contingenza.
Considerare gli outsiders come dei devianti permette di mostrare le asimmetrie di potere che accompagnano la costruzione di veri e propri ghetti cognitivi, in cui degli individui sono riuniti e “naturalizzati”, e consente così di mostrare l’esistenza e la contingenza dei ghetti reali. Il deviante, in fondo, sta lì perché ci è arrivato (il deviante ha una “carriera”) e perché, almeno in una certa misura, è stato fatto arrivare lì. In fondo, quando assumiamo di avere davanti casi di esclusione istituzionalizzata, le cose non cambiano granché: si tratterà sempre di mostrare i meccanismi che originano l’esclusione. Ebbene, entrambe le narrazioni rientrano in quella che potremmo chiamare “topica” politica (30): se assumiamo di avere davanti dei processi contingenti e quindi, almeno in certa misura, diversamente configurabili, ci sarà sempre qualcosa da fare. Una forma del fare è il dire: nella topica politica va fatta rientrare la semplice restituzione di un altro modo di vedere le cose, che è quanto fanno soprattutto gli antropologi (forse perché di solito arrivavano quando non c’era più nient’altro da fare se non attestare (31).
La parola “outsiders”, in quanto vettore di scambi di prospettiva e di ruolo, è una categoria che sembra impegnare l’osservatore. Nell’ammettere che il deviante e l’escluso possono essere altrimenti, che non si tratta di parti esterne alla società ma di suoi prodotti, in ogni caso portatori di un altro sapere sulla e della società (32), l’osservazione tende ad assumere un valore che è anche politico e morale. Così, quando qualifica il proprio atteggiamento verso gli internati psichiatrici come un piccolo risarcimento per la condizione in cui erano stati tenuti (33), Erving Goffman porta allo scoperto il non detto politico che è al fondo non solo di una certa sociologia “critica”, ma di quasi tutte le varietà che, di fatto, compongono il catalogo delle opzioni sociologiche e antropologiche.
L’odio
Resta fuori del quadro, però, il caso di quell’esclusione che non deriva da decisioni istituzionali determinate, ma che innesca “i processi […] forse più estesi e inquietanti” (Prandini 1999, p. 158). Cosa succede, infatti, se assumiamo che non vi sono meccanismi su cui agire in modo localizzato e relativamente razionale? Che vi è sì esclusione, ma non generata da scelte o da cause determinate? La prospettiva di Luhmann permette di ricostruire le condizioni di possibilità di questa esclusione senza colpevoli determinati. Certo, anche in questo caso devono essere all’opera meccanismi sociali, anche in questo caso gli esclusi devono essere prodotti della società, solo che lo sguardo su questi fattori rimane sfocato. Quello che si arriva a sostenere è, in maniera tecnica e insopportabilmente (34) generica, che questa è la logica che regge i sistemi funzionali: il sistema economico, come ogni altro sistema, non può realizzare la piena inclusione, e quando una persona è esclusa da uno di questi sistemi, tenderà a essere esclusa anche dagli altri.
È come se il giudizio universale ci fosse già stato. I buoni sono stati giudicati buoni, gli altri sono stati banditi. Fine della buona volontà, fine della cattiva coscienza. Cancellato il Terzo Mondo d’infausta memoria. Non è servito che alla cattiva coscienza dei ricchi, e tutti gli sforzi per salvarlo sono falliti. Finito. Evviva il Quarto Mondo” (Baudrillard 1986, p. 123).
Quelli che si creano così dei “campi” non recintati che arrivano fino a sotto casa, buoni per la statistica, per l’economia, eventualmente per la TV e i giornali, forse per la sociologia, ma inaccessibili alla politica. Certo, Luhmann non dice che le cose devono necessariamente andare così (35). Inoltre, parlare di esclusione non istituzionalizzata sembra una semplice tesi, vera-o-falsa – e cos’altro deve produrre, l’osservazione della società, se non tesi di questo tipo? A chi scrive, in verità, le cose paiono andare in maniera meno liscia: lo stesso Luhmann (1996, p. 126) avverte che, se questa diagnosi coglie almeno in parte nel segno, la società non può aspettarsi dalla sociologia “né consiglio né aiuto” (36) – ma ciò significa che è prevedibile che la società avrebbe grande bisogno di consiglio e di aiuto, se questa tesi fosse vera! Ora, per la sociologia, in quanto sapere “critico” o comunque “impegnato” a rendersi processabile in una qualche politica sociale, o antropologicamente teso a restituire il punto di vista degli outsiders, ebbene, per ognuna di queste varianti prendere per vera una tesi del genere appare quasi proibito.
Ma lasciamoci perdere, noi e i vincoli morali, politici e istituzionali, non sempre espliciti ma realissimi, che limitano il libero e innocente corso dell’osservazione. In fondo, stare sull’elaborazione sociologica della parola “outsiders” dovrebbe aver insegnato almeno una cosa: che dall’altra parte della medaglia le cose appariranno in modo diverso. Di questo modo di configurare l’esclusione, cosa ne penseranno quelli che vengono classificati come esclusi senza devianza? Luhmann consiglia a chi voglia rendersi conto della realtà dell’esclusione di rivolgersi a chi abbia osato visitare le favelas delle metropoli sudamericane, e ne sia uscito vivo (p. 124). La mia parziale e incerta immaginazione mi porta a dire che l’abitante delle favelas potrebbe aver capito sulla sua pelle il significato della tesi di Luhmann, e aver aggiunto una postilla: è vero che non c’è nessun colpevole, proprio per questo l’odio va esteso al sistema “in sé” (37). E non è detto che occorra andare nelle favelas, per vedere se questa fantasia è reale e se esistono davvero, questi outsiders consapevoli di essere pre-squalificati.
È lo stesso sentimento che nutre, in tutti i popoli non occidentali, questa denegazione viscerale, profonda, di ciò che rappresentiamo e di ciò che siamo. Come se anche questi popoli avessero l’odio. Per quanto si prodighi loro tutta la carità universale di cui siamo capaci, vi è in essi una specie d’alterità che non vuole essere compresa, una specie d’incompatibilità che non vuole essere negoziata. La frattura tra la nostra cultura dell’universale e le restanti singolarità s’inasprisce e si approfondisce. Il loro risentimento può essere impotente, ma, dal fondo del loro sterminio virtuale, una passione di rivincita infiltra e smembra il mondo occidentale, così come il fantasma degli esclusi comincia ad abitare le nostre società convenzionali (Baudrillard 1995, p. 152).
Note
1 Come, del resto, possono avere una biografia le cose, idea che sta al centro di una raccolta di scritti di antropologi, storici e archeologici curata da A. Appadurai (a cura, 1986).
2 E in quanto tale orientato, nel suo complesso, a dare una risposta empiricamente fondata alla seguente domanda: “Com’è possibile la società visto che la spiegazione individualistica dell’ordine sociale è falsa?” (Bortolini 2005, p. 25). La citazione mi dà l’occasione di ringraziare proprio Matteo Bortolini per aver letto e commentato versioni preparatorie di questo testo preparatorio.
3 Sul nesso indissolubile che lega Talcott Parsons e la compagnia dei suoi critici, si vedano Bortolini 2007; Sciortino 1998, p. 122, n. 5.
4 Perlomeno nella prospettiva sociologica cui si fa qui riferimento.
5 In realtà, secondo Luhmann il problema della doppia contingenza si colloca a un livello più radicale, cioè quello della determinabilità stessa dell’azione in quanto azione: il problema, cioè, nasce solo quando una persona incontra un’altra persona o un sistema sociale e gli attribuisce la possibilità della libera scelta – solo a quel punto “il problema diventa attuale quale problema di armonizzazione del comportamento” (Luhmann 1984, p. 208).
6 L’esempio è in Hacking 1999, p. 95.
7 Considerata l’ossessione “quadripartita” di Talcott Parsons, non saprei dire se questo schema sia rivelatore o sarcastico.
8 Significativamente, Elias e Scotson elaborano, in un lavoro quasi coevo, un approccio dinamico alla figurazione radicati-esterni (1965, p. 40).
9 Prima dei molti lavori sociologici o antropologici, si veda Balestrini 1994. Nella ristampa del 2004 (DeriveApprodi), l’opera è introdotta da una presentazione di A. Dal Lago che conferma l’ordine di lettura appena suggerito.
10 Qui spiccano Montaldi 1961 e Dal Lago, Quadrelli, a cura, 2003.
11 Si veda Hacking 1999, oltre che la TV.
12 A volte ci va vicino, ma più per gusto polemico che altro. Le risposte di Becker alle obiezioni mosse ai sostenitori della labelling theory (tra cui, e c’era da aspettarselo, non accetta di essere classificato) sono esposte in un saggio del 1971, che costituisce il decimo capitolo dell’edizione italiana citata in bibliografia.
13 Il riferimento a questa categoria greimasiana non è casuale; si veda infra, n. 32.
14 Nel basket, la visione è periferica se si riesce a vedere non solo quello che succede davanti agli occhi, ma anche di lato e, possibilmente, anche alle spalle. Chi ne è dotato, per esempio Magic Johnson (per questo “Magic”!), riesce a fare passaggi no look, riesce cioè a guardare da una parte e mandare il pallone dall’altra, a un suo compagno libero.
15 Per un esame attento e onesto dei vincoli epistemologici implicati, si veda Dal Lago, Quadrelli, a cura, 2003, in particolare l’introduzione.
16 Peraltro, non sempre provare a fare cose impossibili è insensato: queste medie immaginarie hanno effetti reali e sono spesso socialmente, ed elettoralmente, efficacissime. Lo zelo degli imprenditori morali va misurato con un metro politico e non “scientifico”, atteggiamento che porterebbe solo a stupirsi o a ridere di questa comunità immaginaria, fatta di gente che parla l’italiano della grammatica, che sa dove e quando Garibaldi fu ferito a una gamba e con l’alito senza tracce di caffè o pomodoro.
17 Perché non riflesso, non legato a una qualche “norma”.
18 Questa nozione è al centro dell’ultimo libro di Paul Gilroy (2004).
19 Il rovescio della medaglia è una categoria su cui forse non ha tanto senso riflettere in maniera sistematica, ma che in compenso funziona benissimo: la bega.
20 Il movimento dei “Disobbedienti” incarna sin nel marchio questa strategia, tesa a violare tutte le “zone rosse” disponibili, e forse non è un caso che tale movimento fiorisca proprio in Veneto, terra di norme, devianti, imprenditori, imprenditori morali e, evidentemente, imprenditori devianti.
21 Boltanski aggiunge che queste persone arriveranno al potere con la “sinistra divina” guidata da Mitterand – “divina” perché impossibilitata a fare il Male, essendo “sinistra” e per di più “artista”; la formula è di Baudrillard (1985). Il craxismo prima e, più tardi, ormai fuori tempo massimo, il post-comunismo insider, ne sono stati il corrispettivo in Italia; sull’omologia culturale delle due “sinistre vincenti” di casa nostra, si veda Stella 2000, cap. XIII, dal titolo: “Uno ‘chef à penser’ per la sinistra chiffon”.
22 Che, tra l’altro, implicherebbe un riferimento più complessivo alla prospettiva di M. Perniola, di cui il dandy può essere considerato una figura significativa, ma parziale. Il nucleo di questa produzione può forse essere stenografato così: performare una differenza effettuale. Si tratta di una ricerca che performa (non descrive!) situazioni in cui l’opposizione si mostra più forte della contraddizione e delle stesse strategie post-dialettiche (per esempio, l’ironia post-moderna di G. Vattimo, il sublime “critico” di G. Agamben) – per questo “differenza”. In tale ottica, gli eventi vengono scavati in modo da destabilizzare in actu (“effettualmente”, secondo la lezione di Guicciardini e… dei situazionisti: nessun wishful thinking, nessun fatalismo) la logica della “società dello spettacolo”. Riducendo a formula per comodità del lettore (un lettore si spera giudizioso), si potrebbe dire che il mondo del terzo spirito del capitalismo è il luogo in cui si creano le condizioni effettive, tecnologiche e sociali, per portarsi al di là della “società dello spettacolo” – e, lo si ripete, il dandy è solo una delle figure di questo installarsi nella contemporaneità non conciliato ma nemmeno antagonistico. Le tappe principali di questo percorso sono: Perniola 1977; 1980; 1991; 2001.
23 “Mi chiedo se l’esigenza del rispetto delle regole non faccia passare in second’ordine sia la difficoltà implicita nell’idea di prova, sia l’eccezionalità implicita nell’idea di grandezza” (Perniola 2002, p. 73).
24 Su questo punto si veda Boltanski 1993, p. 197.
25 La conseguenza da trarre, a mio avviso, è riconoscere che il dandy, e lo stesso progetto che si articola attorno alla nozione di ágalma (Perniola 2002) si muovono in uno spazio che non è più quello critico: non è affatto detto che questo sia un limite, a meno che non si assuma che ciò che non è critico sia per ciò stesso ideologico, o necessita di una procedura condivisa di legittimazione. Boltanski stesso (1990) individua nel “regime di pace” un regime d’azione in cui non si pone la questione della giustizia e in cui i modelli della filosofia politica perdono pregnanza. Non è forse questo il tipo di rapporto, cioè di non-rapporto, che lega ágalma e scambio economico, dandy e vita quotidiana?
26 In generale, la “città” è quella specifica costruzione normativa su cui poggia la giustificazione del capitalismo; in particolare, la “città per progetti” è la base della legittimazione del capitalismo delle reti. Sul punto, si veda Boltanski 2002, p. 11-14.
27 Per l’applicazione di questo termine alla semantica dell’esclusione, si veda Prandini 1999, riferimento diretto delle riflessioni che seguiranno.
28 Qui mi distacco dalla ricostruzione del Prandini del 1999, che pone invece l’accento sul fatto che esclusione istituzionalizzata e esclusione non istituzionalizzata sono comunque, entrambi, processi interni alla società. Nel seguito, invece, l’accento verrà posto sulla differenza che distingue l’esclusione non istituzionalizzato.
29 Nella copiosa letteratura sui “campi” segnalo il lavoro di C. Marchetti (2006), che ha il pregio di mostrare i campi “qui” (CPT e simili) e i “campi” là (i campi profughi) senza far mai perdere di vista chi nei campi ci va e chi no, centrando la prospettiva sul caso particolarmente delicato e numericamente imponente dei rifugiati.
30 Il termine (si veda Boltanski 1993, pp. 86-87) indica quegli scenari paradigmatici che favoriscono l’identificazione di esperienze comuni. Nella fondamentale opera che L. Boltanski dedica alla “sofferenza a distanza” e alle tre “topiche della sofferenza”, la semiotica di A. Greimas fornisce gli strumenti fondamentali per l’analisi della forma chiusa e convenzionale delle messe in scena narrative che permettono di tipizzare emozioni, azioni e attanti.
31 In realtà, i numerosi lavori sulla e della “cultura subalterna” non si pensano e non vanno presi come una sorta di estrema unzione. Qui sta tutta l’urgenza, percepita anche da chi scrive, dell’interrogarsi antropologico sull’attualità della nozione di cultura popolare; si vedano Clemente, Mugnaini 2001; Dei 2002.
32 Si veda Dal Lago, Quadrelli, a cura, 2003, pp. 22-23.
33 La circostanza è ricordata sempre in Dal Lago, Quadrelli, a cura, 2003, p. 23.
34 Quando Luhmann parla degli esclusi non ne parla da cinico, ma in modo anti-sentimentale: quella che viene articolata è una vera e propria “denuncia della denuncia” (per questa nozione si veda Boltanski 1993, pp. 149-177).
35 Ovvio: “Nessuno vorrà sostenere che le cose debbano necessariamente andare così, in virtù di una sorta di legge della popolazione di stampo malthusiano” (Luhmann 1996, p. 125).
36 Per un esame del ruolo rivestito dalla morale nel pensiero di Luhmann, si veda Bonaiuti 2005.
37 Questo è lo “spirito del terrorismo” di cui parla J. Baudrillard (2002). Ringrazio Fulvio Carmagnola per avermi stimolato a riflettere sul significato di questo testo.
Bibliografia
Appadurai, A., a cura, 1986, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press.
Balestrini, N., 1994, I Furiosi, Milano, Bompiani.
Baudrillard, J., 1985, La Gauche Divine, Paris, Grasset; trad. it. 1986, La sinistra divina, Milano, Feltrinelli.
Baudrillard, J., 1986, Amérique, Paris, Grasset; trad. it. 2000, America, Milano, SE.
Baudrillard, J., 1995, Le crime parfait, Paris, Galilée; trad. it. 1996, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Milano, Cortina.
Baudrillard, J.,2002, L’esprit du terrorisme, Paris, Galilée; trad. it. 2002, Lo spirito del terrorismo, Milano, Cortina.
Becker, H. S., 1973 [I ed. 1963], Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Glencoe, MacMillan; trad. it. 1987, Outsiders. Saggi di sociologia della devianza, Torino, EGA.
Boltanski, L., 1990, L’Amour et la Justice comme compétence. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié; trad. it. [parz.] 2005, Stati di pace. Una sociologia dell’amore, Milano, Vita e Pensiero.
Boltanski, L., 1993, La Souffrance à distance, Paris, Métailié; trad. it. 2000, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica, Milano, Cortina.
Boltanski, L., Chiapello, È., 1999, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Boltanski, L., 2002, Una nuova componente dello spirito del capitalismo, in «Ágalma», n. 3, pp. 9-21.
Bonaiuti, G., 2005, Teoria della morale contro gli abusi della colpa. L’etica in Luhmann, introduzione a N. Luhmann, Il paradigma perduto, trad. it. Roma, Meltemi.
Bortolini, M.,2005, L’immunità necessaria. Talcott Parsons e la sociologia della modernità, Roma, Meltemi.
Bortolini, M.,2007a, In ordine sparso. Avvertimenti e ipotesi sul non sapere della sociologia, in «Sociologica», 1, 1.
Bortolini, M., 2007b, Laicità locale. Pratiche argomentative e decisioni realizzabili, in A. Santambrogio, a cura, 2007, L’associazionismo cattolico e l’Europa. Laicità, religione e sfera pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Clemente, P., Mugnaini, F., a cura, 2001, Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci.
Coblence, F., Le dandysme, obligation d’incertitude, Paris, P.U.F.
Dal Lago, A., Quadrelli, E., 2003, La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini, Milano, Feltrinelli.
Dei, F., 2003, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi.
Elias, N., Scotson, J. L., 1965, The established and the Outsiders, London, SAGE; tr. it. 2004, Strategie dell’esclusione, Bologna, Il Mulino.
Esposito, E., 2004, I paradossi della moda. Originalità e transitorietà nella società moderna, Bologna, Baskerville.
Gilroy, P., 2004, After Empire. Melancholia or Convivial Culture?, London, Routledge; trad. it. 2006, Dopo l’Impero. Melanconia o cultura conviviale?, Roma, Meltemi.
Hacking, I., 1999, The social contruction of what?, Harvard, Harvard University Press; trad. it. 2000, La natura della scienza. Riflessioni sul costruzionismo, Milano, McGraw-Hill.
Luhmann, N., 1984, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen teorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp; trad. it. 1990, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Bologna, Il Mulino.
Luhmann, N., 1996, Jenseits von Barbarei, in M. Miller e H.-G. Soeffner, a cura, Modernität und Barbarei. Soziologische Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M., Suhrkamp; trad. it. 1999, Oltre la barbarie, in «Sociologia e politiche sociali», a. 2, n. 3, pp. 117-128.
Marchetti, C., 2006, Un mondo di rifugiati. Migrazioni forzate e campi profughi, Bologna, EMI.
Marzocchi, V., 2001, Ragione come discorso pubblico. La trasformazione della filosofia di K.-O. Apel, Napoli, Liguori.
Montaldi, D., 1961, Autobiografie della leggera. Emarginati, balordi, ribelli raccontano la loro storia, Milano, Bompiani.
Perniola, M., 1977, Georges Bataille e il negativo, Milano, Feltrinelli.
Perniola, M., 1980, La società dei simulacri, Bologna, Cappelli.
Perniola, M., 1991, Del Sentire, Torino, Einaudi.
Perniola, M., 2001a, Del sentire cattolico. La forma universale di una religione universale, Bologna, Il Mulino.
Perniola, M., 2001b, Le ultime correnti dell’estetica in Italia, in Storia della letteratura italiana. Il Novecento. Scenari di fine secolo, Milano, Garzanti.
Perniola, M., 2002, Prova di forza o prova di grandezza? Considerazioni sull’ágalma, in «Ágalma», n. 3, pp. 62-79.
Prandini, R., 1999, Dopo la catastrofe della forma. I dilemmi dell’inclusione sociale, in «Sociologia e politiche sociali», a. 2, n. 3, pp. 129-172.
Prandini, R., 2005, La “costituzione” del diritto nell’epoca della globalizzazione. Struttura della società-mondo e cultura del diritto nell’opera di Gunther Teubner, in G. Teubner, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, Roma, Armando, pp. 191-255.
Sciortino, G., 1998, Sul concetto di ordine normativo nella teoria dell’azione, in R. Prandini, a cura, Talcott Parsons, Milano, Mondadori, pp. 98-124.
Stella, G. A., 2000, Chic. Viaggio tra gli italiani che hanno fatto i soldi, Mondadori, Milano.
Thompson, E. P., 1981, L’economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII, in Società patrizia, cultura plebea, trad. it. Torino, Einaudi.
di René Capovin